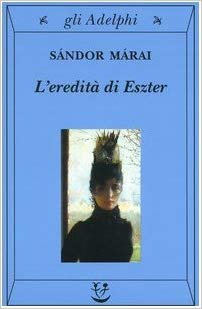“Non so che cosa mi riservi ancora il Signore. Ma prima di morire voglio narrare la storia del giorno in cui Lajos venne per l’ultima volta a trovarmi e mi spogliò di tutti i miei beni”. Inizia così uno dei capolavori di Sándor Márai, “L’eredità di Eszter”, in cui si narra la storia di una donna che vive un’esistenza piana e senza scosse nell’inconsapevole attesa del ritorno di Lajos, il solo uomo che abbia mai amato e che, però, le ha anche rovinato la vita. Lajos è il genio della menzogna, un consumato attore che ogni giorno si esibisce sul palco della vita e a cui Eszter non può fare a meno di guardare con trasporto. Si consuma tra una bugia e l’altra, tra un inganno pronunciato con disinvoltura e una verità gridata con eccessivo fervore – e che, proprio per questo, suonerà sempre finta, posticcia – la storia di due individui destinati a un’eterna infelicità, perché “gli amori infelici non finiscono mai”.
Maestro della parola nonché impavido ricercatore delle debolezze umano, Márai offre sempre al lettore la prova della sua indiscussa, geniale modernità.
1
Non so che cosa mi riservi ancora il Signore. Ma prima di morire voglio narrare la storia del giorno in cui Lajos venne per l’ultima volta a trovarmi e mi spogliò di tutti i miei beni. Rimando ormai da tre anni la stesura di questi appunti. Ora invece mi pare che una voce, contro la quale mi sento impotente, mi esorti a descrivere gli eventi di quella giornata e a riferire tutto ciò che so di Lajos, perché è mio dovere e il tempo a mia disposizione è contato. È una voce inequivocabile. Dunque obbedisco, nel nome del Signore. Non sono più giovane, la mia salute è malferma e tra poco dovrò morire. Temo ancora la morte?... Quella domenica in cui ricevemmo l’ultima visita di Lajos mi guarì anche dalla paura della morte. Forse dipende dal tempo, che non mi ha risparmiata, dai ricordi, che sono spietati quasi quanto il tempo, da uno strano tipo di grazia che viene elargita, secondo gli insegnamenti della mia fede, anche agli indegni e ai ribelli, o forse dipende semplicemente dall’esperienza e dalla vecchiaia, ad ogni modo posso affermare che aspetto la morte con serenità. La vita mi ha colmata di doni meravigliosi e mi ha privata di tutto... Cosa posso aspettarmi ancora? Devo morire, perché questa è la legge e perché ho compiuto il mio dovere. So che «dovere» è una parola grave e ora che la vedo scritta, fissata sulla carta, me ne sento un poco intimorita. È una parola arrogante di cui un giorno bisognerà rispondere di fronte a qualcuno. Per quanto tempo non mi sono resa conto di quale fosse il mio dovere? Ubbidivo, sì, ma controvoglia, strillando e protestando disperatamente. A quei tempi intuii per la prima volta che la morte poteva anche essere una liberazione. Mi resi conto che la morte è assoluzione e pace. Soltanto la vita è lotta e disonore. Com’è stata strana quella lotta! Ho fatto di tutto per mettermi in salvo. Ma il nemico continuava a seguirmi. Ormai so che non poteva agire diversamente: siamo legati ai nostri nemici, che a loro volta non sono in grado di sfuggirci. 2 Se voglio essere sincera – quale altro scopo potrebbe mai avere questo scritto? –, devo confessare che nella mia vita e nelle mie azioni non riesco a trovare la minima traccia dell’ira biblica e della veemenza, né della durezza e della determinazione che caratterizzavano di fronte agli estranei le mie opinioni su Lajos e sul destino che mi è stato riservato. «Compiere il proprio dovere...»: che espressione dura e teatrale! Si vive... finché un bel giorno ci si accorge se si è compiuto il proprio dovere oppure no. Comincio a credere che le grandi decisioni fatali, quelle che determinano il profilo caratteristico del nostro destino, siano molto meno consapevoli di quanto supponiamo nei momenti in cui torniamo al passato per evocarne la memoria. Io, allora, non vedevo Lajos in quella casa da vent’anni ed ero convinta di essere corazzata contro i ricordi. Poi un giorno ricevetti il suo telegramma, che rassomigliava a un libretto d’opera ed era tanto teatrale, pericolosamente puerile e bugiardo quanto tutto ciò che egli aveva detto e scritto, a me e ad altri, vent’anni prima e in tempi ancora più remoti... Aveva un’aria così rivelatrice, promettente e carica di sottintesi, e al tempo stesso era così palesemente bugiardo! Uscii in giardino per raggiungere Nunu col telegramma in mano, mi fermai sulla veranda e dissi ad alta voce: «Lajos sta per tornare!». Non so con quale tono di voce pronunciai quelle parole. Probabilmente non gridai dalla felicità. Devo aver parlato come una sonnambula che viene svegliata all’improvviso. Quello stralunato dormiveglia era durato vent’anni. Per vent’anni mi ero aggirata chissà dove sull’orlo di un precipizio, un passo dopo l’altro, tranquillamente, col sorriso sulle labbra. Ora che mi ero destata, vidi di colpo la realtà così com’era. Ma non mi vennero più le vertigini. Nella realtà, sia in quella della vita che in quella della morte, vi è qualcosa di tranquillizzante. Nunu stava lavorando intorno alle rose. Mi guardò dal basso verso l’alto, curva tra i fiori, strizzando gli occhi abbagliati dalla luce, vecchia e tranquilla: «Ma certo». Riprese il lavoro. Quindi domandò: «Quando arriva?». «Domani» risposi. «Va bene» disse. «Nasconderò l’argenteria». Scoppiai a ridere. Ma Nunu rimase seria. Più tardi venne a sedersi al mio fianco sulla panchina di pietra e lesse il telegramma. «Arriveremo in macchina» scriveva Lajos. Da questo plurale arguimmo che avrebbe portato con sé anche i ragazzi. «Saremo in cinque» continuava. Nunu si mise a pensare a ciò che occorreva, ai polli, al latte, alla panna montata. Chi saranno gli altri due?, ci chiedemmo. «Rimarremo fino a sera» comunicava ancora il dispaccio e poi seguiva uno sproloquio altisonante, una marea di parole di cui Lajos non riusciva a fare economia neanche quando doveva compilare un telegramma. «Cinque persone» disse Nunu. «Arrivano in mattinata e rimangono fino a sera». Le sue labbra vecchie ed esangui si muovevano in silenzio; contava e tirava le somme. Calcolava i costi del pranzo e della cena. Poi disse: «Sapevo che sarebbe tornato ancora una volta. Non ha più il coraggio di presentarsi da solo. Porta con sé i rinforzi: i ragazzi, degli estranei. Ma qui non troverà più niente». Sedevamo in giardino e ci guardavamo. Nunu è convinta di sapere tutto sul mio conto. Forse conosce effettivamente la verità, quella verità semplice e definitiva che nel corso della vita cerchiamo di occultare coprendola con tanti stracci. L’onniscienza di Nunu mi infastidiva sempre un poco. Ma era tanto buona con me e la sua bontà era sempre stata così intelligente e asciutta. Alla fine mi arrendevo ogni volta. Nella nebbia invisibile e attaccaticcia che aveva oscurato la mia vita negli ultimi anni, Nunu era sempre stata un faro dalla luce tenue e mansueta che mi indicava la direzione da seguire. Sapevo che non prevedeva neanche stavolta le eventualità pericolose e terrificanti alle quali pensavo io e che il suo accenno all’argenteria da mettere sotto chiave prima dell’arrivo di Lajos era stato soltanto uno scherzo. Esagera, pensavo. Nunu mi prende in giro. Ma al tempo stesso sapevo che più tardi, all’ultimo momento, avrebbe effettivamente nascosto l’argenteria, così come sapevo che ancora più tardi, quando ormai non si sarebbe trattato dell’argenteria ma di tutto quanto, di tutto ciò che non si poteva nascondere in nessun posto, Nunu sarebbe stata lì da qualche parte accanto a me con le sue chiavi, il suo abito nero della festa, le sue rughe, il suo silenzio e la sua cautela ammiccante. E sapevo anche che a quel punto non c’era più nessuno al mondo, neppure Nunu, che avrebbe potuto essermi di aiuto. Ma tutte queste cose le sapevo inutilmente, e all’improvviso diventai allegra come se non mi sentissi minacciata da nessun pericolo. Ricordo che mi divertii a scherzare con lei. Rimanemmo sedute in giardino ad ascoltare il ronzio ebbro delle vespe nel tepore autunnale. Parlammo sommessamente, a lungo, di Lajos, dei ragazzi, di Vilma, la mia sorella maggiore defunta. Stavamo sedute davanti alla casa, sotto la finestra della stanza nella quale, venticinque anni addietro, era morta mia madre. Sedevamo di fronte ai tigli, vicino alla fila degli alveari di mio padre; ma ormai gli alveari erano vuoti. A Nunu non piaceva perdere tempo con l’apicoltura e un giorno avevamo venduto tutte le nostre diciotto famiglie di api. Eravamo nel mese di settembre e le giornate si susseguivano tiepide e calme. Sedevamo lì con quel senso di sicurezza che conoscevo così bene, che è un poco la sicurezza del naufragio e un poco quella della felicità che non conosce desideri. Ma andiamo!, pensavo, che cosa potrà mai portare via Lajos?... L’argenteria? Che insinuazione ridicola. Cosa possono valere quelle poche forchette d’argento ammaccate. Poi calcolai che Lajos doveva avere più di cinquant’anni. Quell’estate ne aveva compiuti cinquantatré. Le posate d’argento non potevano essergli certamente d’aiuto; ma nel caso che una simile sciocchezza potesse ancora soccorrerlo, era meglio che se le portasse via. Anche Nunu doveva aver pensato qualcosa del genere. Infine sospirò, si alzò e si avviò verso la casa camminando adagio. Giunta sulla soglia della veranda, disse: «Non rimanere troppo a lungo da sola con lui. Invita a colazione Laci, Endre e Tibor, come se fosse una delle solite domeniche in cui vi fate compagnia e scherzate con i fantasmi. Lajos ha sempre avuto paura di Endre, e per di più mi pare che gli debba ancora qualcosa. Ma a chi non deve qualcosa, lui?» aggiunse mettendosi a ridere. «Se ne saranno già dimenticati» risposi e risi anch’io. Lo stavo già difendendo. Cos’altro potevo fare? Lajos è l’unico uomo che abbia mai amato in vita mia. 3 Il telegramma che ci comunicava quella notizia non so se lieta o luttuosa era arrivato sabato verso mezzogiorno. Del pomeriggio e della notte che precedettero l’arrivo di Lajos mi ricordo soltanto vagamente. Nunu aveva ragione: no, ormai non temevo più Lajos. Si può temere qualcuno che amiamo oppure odiamo, qualcuno che si sia dimostrato estremamente buono o spietato o anche volutamente malvagio nei nostri confronti. Ma Lajos non era mai stato crudele con me; d’altra parte non si può certo dire che fosse buono nel senso stabilito dai manuali scolastici. Era malvagio? Non ho mai avuto questa sensazione. Mentiva, è vero, ma mentiva come urla il vento, con una specie di forza primordiale, con allegria indomabile. Riusciva a mentire in modo incredibilmente pittoresco. A me, per esempio, aveva mentito dicendo di amarmi, di amare soltanto me. Poi aveva sposato mia sorella Vilma. Ma più tardi mi sono accorta che tutto questo non lo aveva progettato in anticipo, che nelle sue azioni non era mai stato guidato dal malanimo, da calcoli meschini o da un’intelligenza perversa. Aveva detto di amare me – e neppure oggi dubito delle sue parole –, ma poi aveva sposato Vilma, forse perché lei era più graziosa, perché quel giorno tirava la tramontana, o perché Vilma aveva voluto così. Non mi disse mai il motivo della sua decisione. La notte che precedette la domenica in cui Lajos sarebbe tornato a casa – per l’ultima volta in vita sua, lo sapevo bene – rimasi desta fino a tardi. Continuavo a riordinare vecchi oggetti carichi di ricordi, mi preparavo alla sua visita; prima di coricarmi rilessi le sue vecchie lettere. Ancora oggi sono fermamente convinta – e questa strana convinzione quasi superstiziosa fu rafforzata da quella lettura – che in Lajos si celava una misteriosa fonte di energia, come in certe minuscole vene d’acqua che attraversano con mille rivoli l’interno di una montagna, ma poi si perdono per strada, e scompaiono nelle profondità delle caverne senza lasciare traccia. Questa forza non era stata incanalata né utilizzata da nessuno. Ora che alla vigilia della sua visita improvvisa stavo leggendo le sue lettere, rimasi affascinata da quel profluvio di energia senza scopo. In ciascuna di esse egli mi apostrofava con una veemenza, una forza che sarebbe bastata a smuovere non soltanto un essere umano – per non parlare di una donna sentimentale – ma anche interi gruppi di uomini e forse addirittura delle masse. Ciò che diceva non era particolarmente «profondo» e dal modo in cui lo formulava non traspariva la minima inclinazione per la scrittura, le immagini erano sciatte e lo stile trasandato; in compenso, l’intonazione di tutto quello che scriveva era unicamente, inconfondibilmente sua. Scriveva sempre della realtà, di una qualche realtà immaginaria che aveva appena incontrato e che voleva farmi conoscere immediatamente. Non parlava mai dei suoi sentimenti né dei suoi progetti. Descriveva la città in cui si trovava in quel momento con tale forza espressiva che se ne vedevano le strade, la camera in cui stava scrivendo la sua lettera, si udivano le voci delle persone che il giorno prima gli avevano detto qualcosa di intelligente o di spiritoso. Oppure abbozzava un’idea grandiosa nata nella sua mente in quel preciso istante. Tutto ciò prendeva vita in maniera straordinariamente persuasiva nelle lettere di Lajos. A parte il fatto – e questo lo avrebbe avvertito anche il lettore meno attento – che nulla di ciò che diceva era vero, o meglio tutto era vero, ma in un altro senso, in una dimensione diversa da quella da lui descritta, e la città delineata con la fedeltà di un cartografo esisteva, con ogni evidenza, soltanto sulla luna. Egli si accaniva a illustrare con precisione meticolosa questa realtà fittizia, nella stessa maniera in cui descriveva uomini e paesaggi, con serietà e abbondanza di particolari. Rilessi le sue lettere e mi sentii commossa. Forse eravamo stati tutti troppo deboli per riuscire a tenergli testa. Verso mezzanotte, intorno alla casa si scatenò un vento caldo, impetuoso; mi alzai dal letto per chiudere le imposte. E in quell’ora notturna, con una debolezza tutta femminile che non tento neanche di giustificare, mi fermai davanti al grande specchio che un tempo scintillava sopra il tavolino da toilette di mia madre e mi sottoposi a un esame scrupoloso. Sapevo di non essere ancora vecchia. Per qualche singolare capriccio del destino, i vent’anni passati avevano lasciato poche tracce sul mio aspetto. Non sono stata mai brutta, ma non ero neppure una di quelle bellezze che attraggono gli uomini; li inducevo piuttosto al rispetto e a una sorta di languido struggimento. Grazie ai lavori di giardinaggio, o alla mia conformazione fisica, non ero ingrassata: ero alta, dritta e ben proporzionata. Negli ultimi anni i miei capelli si erano un po’ ingrigiti; ma i fili bianchi si confondevano senza dare nell’occhio con il biondo chiaro della mia capigliatura, che è sempre stata la mia caratteristica più spiccata. Intorno agli occhi e alla bocca il tempo aveva segnato una ragnatela di rughe sottilissime; e le mie mani non erano più quelle di una volta, i lavori di casa le avevano rese un po’ ruvide. Eppure adesso mi osservavo allo specchio come una donna che aspetta il suo innamorato. Questo naturalmente era ridicolo. Avevo compiuto quarantacinque anni, Lajos viveva da parecchio tempo con un’altra e forse si era addirittura risposato. Negli ultimi anni non avevo più avuto sue notizie. Ogni tanto avevo letto il suo nome sui giornali, una volta in relazione a un processo politico che aveva suscitato grande scalpore. Non mi sarei affatto meravigliata se un giorno il suo nome avesse acquistato una certa notorietà, in senso buono o cattivo. Ma il rumore intorno allo scandalo si placò presto e il suo nome riapparve sui giornali un’altra volta soltanto, quando si batté a duello nel cortile di una caserma e sparò un colpo in aria senza rimanere ferito. Tutto questo: sia il duello che il fatto di non essere stato ferito, andava così perfettamente d’accordo col suo carattere! Né mi risulta che sia mai stato seriamente ammalato. Il suo destino è diverso, mi dissi. E me ne tornai a letto con le mie lettere, i miei ricordi e l’amara consapevolezza di una gioventù sprecata. Mentirei se affermassi di essermi sentita particolarmente infelice in quei momenti. C’era stato, è vero, un periodo, venti, ventidue anni prima, in cui ero stata infelice. Ma poi quel sentimento si era coagulato in me come il sangue si coagula sulla ferita. Non so quale forza ignota riuscì a tamponare lo stillicidio del dolore dentro di me. Esistono ferite per le quali il tempo non porta guarigione. Sapevo che neanch’io ero guarita. Già qualche anno dopo la nostra separazione – è un’impresa molto difficile trovare delle parole che esprimano esattamente ciò che è accaduto fra Lajos e me – quello che prima mi era sembrato insopportabile divenne a un tratto più naturale, più semplice. Ormai non sentivo più la necessità di chiedere continuamente aiuto a qualcuno, non gridavo perché accorressero le guardie, non invocavo medici o sacerdoti. Vivevo, in qualche modo... E un bel giorno vidi nuovamente riunirsi della gente intorno a me, persone che sostenevano di aver bisogno della mia presenza. Poi ricevetti anche due proposte di matrimonio: la prima da parte di Tibor, che è un poco più giovane di me, e la seconda da Endre, che soltanto Nunu onora del titolo di «zio», benché non sia affatto più anziano di Lajos. Riuscii ad appianare in qualche modo quel contrattempo che rassomigliava a un piccolo incidente. I pretendenti rimasero miei buoni amici. Una notte mi dissi perfino che la vita, in modo inspiegabile, era stata più clemente con me di quanto avessi mai osato sperare. 4 Dopo la mezzanotte Nunu venne in camera mia. Nella nostra casa non esiste ancora la corrente elettrica – la mamma non tollerava questa novità e dopo la sua morte siamo state noi a rinviarne l’introduzione per motivi di risparmio –, sicché le visite notturne di Nunu assumono sempre un’aria lievemente teatrale. Anche quella volta si fermò sulla soglia reggendo un lume tremolante, con i capelli bianchi arruffati e la lunga camicia da notte che la rendevano simile a un’apparizione notturna. «Lady Macbeth,» dissi sorridendo «accostati al mio letto e siediti». Ero certa che durante la notte mi avrebbe fatto visita. Nunu è la parente che in casa ha assunto il ruolo di tutti i parenti. Si presentò da noi trent’anni fa, durante una di quelle migrazioni familiari la cui leggenda si tramanda in tutti i parentadi: proveniva da un’epoca antidiluviana, da un complicato universo tribale brulicante di zie e di cugine. Era venuta a trovarci per poche settimane. Poi era rimasta perché avevamo bisogno di lei. Più tardi non se n’era andata perché tutti quelli che la precedevano nella gerarchia familiare erano morti, mentre Nunu, come in un ufficio statale, ogni dieci anni avanzava un passo dopo l’altro verso le cariche più elevate della famiglia. Un giorno morì la nonna e lei, trasferendosi nella sua camera al primo piano, ne assunse l’ufficio e le competenze. Quindi morirono mia madre e poi Vilma. Un bel giorno Nunu si accorse che ormai non sostituiva più nessuno; si rese conto che lei, l’estranea, l’ultima arrivata, ormai rappresentava la famiglia vera e propria. Il successo di questa intricata carriera non le diede mai alla testa. Nunu non cercò mai di diventare la mia seconda madre né si mise a recitare la parte di genio tutelare della nostra stirpe. Col passar degli anni si fece sempre più parca di parole; diventò sempre più realista, di un realismo secco e spietato, come se l’avventura della vita non avesse più nulla di nuovo da offrirle, e indifferente come un mobile. Fu Laci a dire una volta che Nunu ormai aveva acquistato una patina come un vecchio armadio di noce. Si vestiva sempre allo stesso modo, indossava d’estate e d’inverno un abito confezionato con una stoffa che non era né seta né panno e che ai miei occhi, ma anche a quelli di chi non la conosceva, le conferiva un’aria lievemente solenne. Negli ultimi anni si limitava a pronunciare soltanto le parole indispensabili. Della sua vita non aveva mai detto nulla. Sapevo che voleva condividere tutte le mie preoccupazioni e le mie malinconie; ma lo faceva in silenzio, e quando finalmente apriva bocca era come se stessimo discutendo appassionatamente dello stesso argomento da mesi interi, finché Nunu, con una breve frase, non metteva fine alla nostra disputa. Fu così che disse, sedendosi sull’orlo del mio letto: «Hai fatto esaminare l’anello?». Mi misi a sedere anch’io massaggiandomi le tempie. Sapevo a cosa alludeva e sapevo anche che aveva ragione, benché non avessimo mai parlato di quell’argomento. Forse l’anello non glielo avevo mai fatto vedere, eppure ero certa che anche stavolta avrebbe finito per avere ragione: l’anello era falso. Lo avevo intuito anch’io. Nunu aveva un fiuto incredibile per certe cose. Quando avrà sentito parlare dell’anello?, mi chiesi; ma poi lasciai perdere la questione, perché era addirittura ovvio che Nunu fosse al corrente di tutto ciò che riguardava la casa, la famiglia, la mia persona e la mia vita, che conoscesse tutto ciò che si nascondeva in cantina, in soffitta o nella vita della mia sorella defunta: ecco perché sapeva anche dell’anello. Avevo quasi dimenticato quella vecchia storia a cui pensavo malvolentieri. Quando Vilma era morta, Lajos mi aveva dato quel gioiello, l’anello della nonna: una pietra preziosa con l’incastonatura di platino che era l’unico oggetto di valore della famiglia. Non ho idea di come avesse fatto a rimanere in nostro possesso – persino il babbo lo rispettava e lo trattava con cautela quasi superstiziosa, lui che si era disfatto così alla leggera delle sue terre e di tanti oggetti di valore. Come certi famosi diamanti di proprietà delle famiglie reali, i Koh-I-Noor o altri monili storici che nessuno pensa a valorizzare sul mercato e che vengono usati solo per farli risplendere nelle ricorrenze più solenni al dito di un nobile membro della famiglia, così noi custodivamo da quattro generazioni il nostro anello, «l’anello». Il suo vero valore non l’ho mai conosciuto. Indubbiamente era abbastanza elevato, anche se non esorbitante come voleva la leggenda familiare. Dalla nonna il gioiello passò alla mamma e poi a Vilma. Quando Vilma morì, Lajos si commosse e in uno dei suoi momenti di sentimentalismo mi costrinse ad accettarlo.