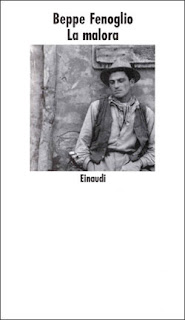LA MALORA
Beppe Fenoglio
Pioveva su tutte le langhe, lassù a San Benedetto mio padre si pigliava la sua prima acqua sottoterra. Era mancato nella notte di giovedì l'altro e lo seppellimmo domenica, tra le due messe. Fortuna che il mio padrone m'aveva anticipato tre marenghi, altrimenti in tutta casa nostra non c'era di che pagare i preti e la cassa e il pranzo ai parenti. La pietra gliel'avremmo messa più avanti, quando avessimo potuto tirare un po' su testa. Io ero ripartito la mattina di mercoledì, mia madre voleva mettermi nel fagotto la mia parte dei vestiti di nostro padre, ma io le dissi di schivarmeli, che li avrei presi alla prima licenza che mi ridava Tobia. Ebbene, mentre facevo la mia strada a piedi, ero calmo, sfogato, mio fratello Emilio che studiava da prete sarebbe stato tranquillo e contento se m'avesse saputo così rassegnato dentro di me. Ma il momento che dall'alto di Benevello vidi sulla langa bassa la cascina di Tobia la rassegnazione mi scappò tutta. Avevo appena sotterrato mio padre e già andavo a ripigliare in tutto e per tutto la mia vita grama, neanche la morte di mio padre valeva a cambiarmi il destino. E allora potevo tagliare a destra, arrivare a Belbo e cercarvi un gorgo profondo abbastanza. Invece tirai dritto, perché m'era subito venuta in mente mia madre che non ha mai avuto nessuna fortuna, e mio fratello che se ne tornava in seminario con una condanna come la mia. Mi fermai all'osteria di Manera, non tanto per riposarmi che per non arrivare al Pavaglione ancora in tempo per vedermi dar del lavoro; perché avrei fatto qualche gesto dei più brutti. Tobia e i suoi mi trattarono come un malato, ma solo per un giorno, l'indomani Tobia mi rimise sotto e arrivato a scuro mi sembrava di non aver mai lavorata una giornata come quella. Mi fece bene. Un po' come fa bene, quando hai lavorato tutta notte nella guazza a incovonare, non andartene a dormire ma invece rimetterti a tagliare al rosso del sole.
Come la mia famiglia sia scesa alla mira di mandare un figlio, me, a servire lontano da casa, è un fatto che forse io sono ancora troppo giovane per capirlo da me solo. I nostri padre e madre ci spiegavano i loro affari non più di quanto ci avrebbero spiegato il modo che ci avevan fatti nascere: senza mai una parola ci misero davanti il lavoro, il mangiare, i quattro soldi della domenica e infine, per me, l'andare da servitore.
Non eravamo gli ultimi della nostra parentela e se la facevano tutti abbastanza bene: chi aveva la censa, chi il macello gentile, chi un bel pezzo di terra propria. L'abbiamo poi visto alla sepoltura di nostro padre, arrivarono ciascuno con la bestia, e non uno a piedi da poveretto.
Dovevamo sentirci piuttosto forti se, quando io ero sugli otto anni, i miei tirarono il colpo alla censa di San Benedetto. La presero invece i Canonica coi soldi che s'erano fatti imprestare da Norina della posta. Nostro padre aveva troppa paura di far debiti, allora.
Adesso mi è chiaro che nostro padre aveva già staccata la mente dal lavorare la terra e si vedeva già a battere con carro e cavallo i mercati d'Alba e di Ceva per il fabbisogno della sua censa, e quando dovette invece richinarsi alla terra, aveva perso molto di voglia e di costanza. Noialtri ragazzi lavoravamo sempre come prima, anche se lui ci comandava e ci accudiva meno, ma a mezzogiorno e a cena ci trovavamo davanti sempre più poca polenta e quasi più niente robiola. E a Natale non vedemmo più i fichi secchi e tanto meno i mandarini.
Nostra madre raddoppiò la sua lavorazione di formaggio fermentato, ma non ce ne lasciava toccare neanche le briciole sull'orlo della conca. E quando seppe che a Niella ne pagavano l'arbarella un soldo di più che al nostro paese, andò a venderlo a Niella, e saputo poi che a Murazzano lo pagavano qualcosa meglio, si faceva due colline per andarlo a vendere lassù. Dimodoché diventò in fretta come la sorella maggiore di nostro padre, sempre col cuore in bocca, gli occhi o troppo lustri o troppo smorti, mai giusti, in faccia tutta bianca con delle macchie rosse, come se a ogni momento fosse appena arrivata dall'aver fatto di corsa l'erta da Belbo a casa. Quando noi eravamo via, lei pregava e si parlava ad alta voce: una volta che tornai un momento dalla terra, la presi che cagliava il latte e si diceva: - Avessi adesso quella figlia! - Diceva di nostra sorella, nata dopo Stefano e morta prima che nascessi io, d'un male nella testa. Si chiamava Giulia come nostra nonna di Monesiglio, e a Stefano non so, ma a me e a Emilio non ci mancava. Però anche allora io non sono mai passato davanti al camposanto guardando da un'altra parte, come un padrone che passa davanti alla sua terra.
Ci andava male: lo diceva la misura del mangiare e il risparmio che facevamo della legna, tanto che tutte le volte che vedevo nostra madre tirar fuori dei soldi e contarli sulla mano per spenderli, io tremavo, tremavo veramente, come se m'aspettassi di veder cascare la volta dopo che le è stata tolta una pietra. Finì che nelle sere d'autunno e d'inverno mandavamo Emilio alla cascina più prossima a farsi accendere il lume per avanzare lo zolfino. Io ci andai una volta sola, una sera che Emilio aveva la febbre, e quelli del Monastero m'accesero il lume, ma la vecchia mi disse: - Va', e di' ai tuoi che un'altra volta veniamo noi da voi col lume spento, e lo zolfino dovrete mettercelo voi.
Nostro padre vendette mezza la riva da legna e anche quel prato che avevamo lungo Belbo, ma il denaro di quelle vendite non ci fece pro, andò quasi tutto a pagare le taglie e a far star bravi i Canonica che non ci togliessero il credito alla censa. E' allora che i nostri s'indebitarono con la vecchia maestra Fresia di quelle cento lire che hanno poi scritto il destino di mio fratello Emilio.
Per chiedere la grazia di poter tirar su testa, un anno nostra madre andò pellegrina al santuario della Madonna del Deserto, che è lontano da noi, sopra un monte dietro il quale si può dire che c'è subito il mare. Mi ricordo come adesso. Era un po' che noi, alzata la schiena, guardavamo la processione delle donne sulla strada di Mombarcaro, quando esce di casa nostra madre, vestita da chiesa, e con un fagottino di roba mangiativa. Nostro padre le uscì appresso e le gridava: - Vecchia bagascia, non mi vai mica via con quello stroppo di pelandracce? - Lei si voltò, ma senza fermarsi e solo per guardarlo negli occhi. E lui sempre dietro, con un principio di corsa come per assicurarsi d'acchiapparla. E nel mentre le diceva: - Mi torni indietro fra chissà quanti giorni, con tutti i piedi gonfi e tutto il corpo stracco che per una settimana non mi puoi più servire -. Allora lei si fermò e gli disse: - Lasciami andare, Braida. Sono sette anni che non esco da questa casa. Lasciami andare, che è per la mia anima.
- L'anima vola! - le gridò lui in faccia, ma poi le disse: - Donna con del buon tempo. Hai almeno lasciato preparato?
Poté partire, e dopo un po' la vedemmo mischiarsi alla processione. Aveva un buon passo e presto fu tra le prime, e non solo dal passo si vedeva che aveva buona intenzione, ma anche perché non si voltava e non cercava compagne, mentre tutte le altre andavano come per divertimento. Tornò di notte, dopo quattro giorni, e la mattina si levò alla sua ora di sempre e fece il suo lavoro di tutti i giorni. Ma non giovò, Dio non fu mai con noi.
Poi il re chiamò Stefano a soldato, andò alla leva e tirò un numero basso. Nostro padre bestemmiò, nostra madre pianse, ma Stefano lui era contento: lo sentii quella sera, che io ero in pastura vicino a dove lui tutto nudo si lavava in Belbo, gridare d'allegria, ma dei gridi selvaggi che misero paura a me e alle pecore. Basta, stette a casa ancora due mesi, se ne andava al sabato coi suoi soci coscritti a fare il giro delle osterie della nostra langa e tornava solo nella notte del lunedì, ubriaco che dovevamo sbatterlo nella stalla. E poi partì, una notte che noialtri due non fummo neanche svegliati.
Ci scriveva, e leggevamo che era in artiglieria e a Oneglia. Di questa città io non sapevo altro che era in riva al mare, avrei aspettato che venisse in licenza per domandargli qualche cosa sul mare. Ma Stefano in licenza non veniva, mandò solo una sua fotografia, per vederla bisognava entrare nella stanza dei vecchi, era là appesa a un cordino in mezzo ai rametti d'ulivo e alle candele benedette. Una volta ci scrisse che lui non era di quei soldati che sudano a far l'istruzione e le marce, lui più furbo s'era messo da attendente a un ufficiale e stava benone. Allora i nostri fecero prender la penna in mano a Emilio e scrivere a Stefano che ci mandasse la deca se stava tanto bene. Da quella lettera non ci scrisse più, da lui non vedemmo un centesimo e in licenza non ci venne mai. Noi a casa non ce la facevamo a scalare uno scudo dal debito con la maestra.
Lo congedarono dopo ventun mesi, s'era fatto più massiccio e più superbo, gli ci volle un mese buono per riabituarsi al lavoro e ripigliarlo, adesso andava tutte le sere all'osteria e tante notti rientrava ubriaco del vino che gli offrivano in paga del suo raccontare. Con noialtri suoi fratelli sembrava che crepasse a parlare un po' del mare e di quei posti che aveva visto, ma all'osteria il mazzo ce l'aveva sempre lui e parlava solo sempre di donne forestiere che faceva schifo. S'era rimesso a lavorare con me dietro le bestie che Emilio conduceva, ma io che avevo i bracci metà dei suoi rendevo il doppio di lui sul lavoro, lui alzava la schiena ogni cinque minuti e guardava sovente al passo della Bossola.
Tornato Stefano in famiglia, venne l'ora d'Emilio di partire: andò a studiare da prete nel seminario di Alba. Avevamo potuto scalare sì e no due scudi dal debito con la maestra, e lei trovandosi con un piede nella tomba e senza nessuna necessità di riavere le sue cento lire, c'era venuta una sera in casa a dire ai nostri che ci rimetteva il debito se le mandavamo il nostro Emilio a farsi prete. Non solo ci rimetteva il debito, ma ci passava uno scudo al mese per il suo mantenimento in seminario e qualche altra lira l'avrebbe fatta sborsare al parroco.
Emilio non disse niente, come niente dissi io davanti a Tobia Rabino che diventava mio padrone, i vecchi dissero di sì abbastanza in fretta.
Il motivo può anche aver offeso nostro Signore, ma però mio fratello Emilio a fare il prete andava bene, prima di tutto perché Emilio era buono, e quello che in chiesa ci stava di più e meglio, e poi a scuola era il primo di tutto San Benedetto, e i miei, quando avevano qualche cosa da chiedere al cielo, era lui che facevano pregare, perché era il più innocente. E poi era di poche forze, cosa poteva fare senza penare era solo stare davanti alle bestie.
Partì per il seminario un sabato mattina, sul biroccio di Canonica che andava a fare il mercato ad Alba. Lo baciammo tutti sulle guance, prima che montasse. Nostra madre piangeva, nostro padre le dava dei nomi perché piangeva e le disse: - O stupida, quando io ti mancherò, cosa ti sogni di meglio che andare a star con lui dove sarà parroco e fargli da perpetua? - C'era Stefano, io che non mi capacitavo che tra cinque minuti sarei stato sulla terra senza più Emilio vicino, c'era la maestra Fresia che parlava italiano con Emilio. Il parroco non c'era, ma Emilio era stato in canonica la vigilia a sentire come doveva comportarsi in seminario i primi tempi.
Canonica non si fidava a dare al cavallo perché sentiva i pianti di nostra madre, le venne vicino la maestra e le disse: - Melina, ma pensate alla consolazione di quando dirà la sua prima messa. E voi sarete la prima a ricevere la sua ostia -. Poi nostro padre fece un segno a Canonica e partirono. Non ci avrei creduto chi m'avesse detto che l'avrei rivisto prima che fosse passato l'anno, e proprio in Alba, dove sarei andato col mio padrone Tobia..
A me toccò che andavo per i diciassette anni e a dispetto della carestia di casa nostra pesavo sette miria, ero tanto grosso d'ossa. Quando mi misi a dormire quella notte, sapevo che l'indomani nostro padre sarebbe andato al mercato di Niella, ma da solo, sicché mi diede uno scrollone la sua voce nello scuro della prima mattina: - Agostino, levati e vestiti da chiesa -. Non dirò sicuramente che fu un presentimento: tutto capitò come se io fossi un agnello in tempo di Pasqua.
Andare ai mercati mi piaceva, ed è a un mercato che ho avuto la mia condanna. Non successe subito, potei girare ben bene il mercato di Niella e m'incrociai più d'una volta con l'uomo della bassa langa che un'ora dopo m'avrebbe tastato le braccia e misurato a spanne la schiena e contrattato poi con mio padre il mio valore.
Disse Tobia Rabino: - Vi do per lui sette marenghi l'anno.
E mio padre: - Me lo pagate un marengo per miria che pesa.
Io pensavo solamente, in mezzo a tutte quelle parole, che mia madre a casa lo sapeva ed era come se fosse lì con noi sul mercato di Niella. Mi sembrava che mio padre e Tobia giocassero a gridare, e la voce più forte quella di mio padre.
Si toccarono la mano e Tobia disse ancora: - Se mi contenta, gli regalerò un paio di calzoni per ogni Natale che passa a casa mia. Ma non fateci subito calcolo, non lo metto nei patti.
- E fatelo lavorare! - gli gridò mio padre, ma la sua non era crudeltà verso di me, ma solo una sfida a quell'uomo della bassa langa a spezzare col lavoro la razza dei Braida.
Partii per il Pavaglione una settimana dopo, a piedi, per la strada insegnatami da Tobia. Mi sentivo nelle vene sangue d'altri che avevano già servito.
Quasi tre anni sono restato al Pavaglione, e adesso ci manco da cinque mesi, ma mi sembra ieri sera che ci arrivai la prima volta, e al bordello del cane Tobia mi si fece incontro sull'aia e nel salutarmi mi tastava spalle e braccia per sentire se in quella settimana i miei non m'avevano lasciato deperire apposta.
Di chi proprio non posso lamentarmi è la donna di Tobia. Alla prima vista trovò che avevo l'aria brava e mi prese in stima e a benvolere. Mai una volta che abbia scorciato i capelli ai suoi figli senza poi farmi passar anche me sotto le forbici e la scodella, e tante sere d'inverno, dopo d'aver richiamato alla catena il cane alla larga nel bosco, entrava col lume nella stalla a vedere se ero ben coperto. E m'accudì anche meglio quando seppe che avevo un fratello che studiava da prete. Io che Tobia lo chiamavo per nome, a lei diedi sempre della padrona.
Lei e Tobia hanno tre figli. La prima si chiamava Ginotta, io non l'ho conosciuta tanto perché andò via sposa che io ero a casa sua da solo sei mesi: quando ci arrivai, già due sensali salivano per lei al Pavaglione. Non ho potuto conoscerla tanto Ginotta, ma è stato vivendo quel poco accanto a lei che mi son fatto un'idea di quel che avrebbe potuto valere in famiglia quella nostra sorella se la sua vita fosse durata, e mi sono persuaso che non sarebbe cambiato niente.
I due maschi, uno è un po' più vecchio di me e l'altro un po' più giovane. Con loro ci facevo quattro parole a testa al giorno, ma nessuno dei due m'ha mai trattato con prepotenza, forse perché sapevano bene che bastava una tempesta un po' arrabbiata e un piccolo conto nella testa di loro padre per spedirli tutt'e due a far la mia medesima fine lontano da casa. Tant'è vero che delle volte Tobia gli comandava qualche lavoro mentre c'ero io lì magari con le mani in mano e loro se lo facevano senza neanche sognarsi di passarlo a me.
Per venire a Tobia, lui m'ha sempre trattato alla pari dei suoi figli: mi faceva lavorare altrettanto e mi dava altrettanto da mangiare. A lavorare sotto Tobia c'era da lasciarci non solo la prima pelle ma anche un po' più sotto, bisognava stare al passo di loro tre e quelli tiravano come tre manzi sotto un solo giogo. Almeno dopo tutta quella fatica si fosse mangiato in proporzione, ma da Tobia si mangiava di regola come a casa mia nelle giornate più nere. A mezzogiorno come a cena passavano quasi sempre polenta, da insaporire strofinandola a turno contro un'acciuga che pendeva per un filo dalla travata; l'acciuga non aveva già più nessuna figura d'acciuga e noi andavamo avanti a strofinare ancora qualche giorno, e chi strofinava più dell'onesto, fosse ben stata Ginotta che doveva sposarsi tra poco, Tobia lo picchiava attraverso la tavola, picchiava con una mano mentre con l'altra fermava l'acciuga che ballava al filo.
Dopo queste cene, Tobia pretendeva che dopo si cantasse; soffiava sul lume e diceva ai figli di cantare. Loro cantavano, e anche allo scuro s'indovinava che Tobia sorrideva come se gli si lisciasse il pelo. Io non potevo aggiungermi perché non sapevo nessuna delle loro canzoni, ma poi le imparai tutte perché così volle Tobia, me lo disse come il comando d'un lavoro sulla terra.
Tante di quelle volte, nella stalla, sul mio paglione, aspettando che mi si addormentasse la pancia perché potesse addormentarsi anche la testa, mi sono domandato se alla fine della mia annata non c'era pericolo di non toccar quei sette marenghi. E pensavo anche a come faceva Ginotta, che pativa la nostra stessa fame, ad avere quell'aspetto, che sembrava già una sposa del primo anno.
Venni presto in chiaro del perché lavoravano così da demoni e tiravano tanto la cinghia, da un discorso d'interesse che si fecero dietro la casa Tobia e suo figlio più vecchio. Io ero lì per mio conto, che guardavo il rittano di Sant'Elena e aspettavo che da dentro mi chiamassero a mangiare, quando girano la casa Tobia e suo figlio Jano. Si sedettero sui talloni, il vecchio sputò in terra, il figlio sputò sul bagnato del padre, di nuovo sputò Tobia e di nuovo Jano.
Poi Tobia disse: - Siamo a una buona mira, Jano.
- Ma se lo dicevi già quando m'hai messo al mondo!
- Ti dico che adesso siamo a una buona mira.
- E per quando sarebbe?
- Tu adesso dovresti avere quasi diciannove anni. Be', per quel giorno glorioso non sarai ancora un uomo.
- Ma io sono un uomo già adesso!
Tobia si mise a ridere: - Sì che sei già un uomo. Tu non sei mio figlio, sei il mio avvocato. Senti qui cosa ho io nella mia mente -. Ma proprio allora la padrona mise le mani all'inferriata della cucina e ci gridò d'entrare a mangiare. Tobia le urlò: - Aspetta, bagascia. Stiamo parlando tra noi uomini -. E poi disse a Jano: - Ho in mente una dozzina di giornate, non di più, ma tutte a solatio, da tenere mezze a grano e mezze a viti. Con una riva da legna e anche un pratolino da mantenerci due pecore e una mula. Per concimarlo basterà la cenere del forno.
- E dove sarebbe questa terra?
Tobia si alzò sui ginocchi per tirare più comodo un peto e poi si riabbassò: - Mica qui, mica su questa langa porca che ti piglia la pelle a montarla prima che a lavorarla. Io me la sogno su una di quelle collinette chiare subito sopra Alba, dove la neve ha appena toccato che già se ne va.
Quindi io sapevo i piani dei Rabino, e questo mi fece solo star male. Non me ne sarebbe fatto niente se con quel mio lavoro da galera io li avessi aiutati solo a togliersi la fame e il freddo, ma che mi pigliassero la pelle per arrivare a farsi roba loro proprio mentre a casa noi perdevamo il nostro bene tavola a tavola, questo mi mise l'invidia e un veleno nella mia stanchezza.
Per certo che per far quella riuscita Tobia non ne perdonava neanche mezza. Un giorno andiamo io e lui col carro giù a Trezzo a macinare. Al ritorno Tobia mi diede da pensare perché un bel po' prima di casa mi venne accanto e dettomi: - Tornatene da solo che ormai sei buono, - passò avanti con un'andatura che non gli avrei mai fatta. Quando arrivai per mio conto al Pavaglione e fermai il carro al cancello, c'erano sull'aia i tre figli, talmente fissi all'uscio della cucina che neanche s'accorsero di me. Sull'aia e dentro la casa c'era tutto silenzio, salvo il suono della cinghia per aria e il suo botto sulla schiena della padrona. Poi Tobia uscì con la cinghia sempre in mano, venne a piantarsi in mira ai figli e dài giù a cinghiare: - Che vi diventi tossico nelle budelle! - urlava a ogni colpo, - che vi diventi tossico nelle budelle! - finché gli mancò la voce, ma non il braccio per cinghiare ancora. Ebbene, nessuno dei tre che si torcesse o che si lamentasse, neanche Ginotta. Intanto loro l'avevano mangiato il coniglio, mentre noi eravamo giù al mulino, e Tobia era arrivato a prenderli solo più con gli ossi.
Padrone del Pavaglione era, e lo sarà ancora, un signore d'Alba, che aveva la più bella farmacia d'Alba; delle volte Tobia si vantava perfino lui che il suo padrone avesse la prima farmacia che ci fosse in Alba, eppure quando lo nominava lo chiamava padrone di merda e gli augurava una morte secca. Si lagnava soventissimo d'avercelo sempre addosso, e a me questo faceva strano perché in tutta quella mia prima annata al Pavaglione il padrone io lo vidi solo due volte: una giù ad Alba, che gli portammo un acconto della sua parte, e l'altra venne su lui in domatrice con un suo amico anche d'Alba, un avvocato. Era di febbraio, e avevano la scommessa se la neve andava via prima al Pavaglione oppure alla cascina di quell'avvocato. Dopo d'aver ben guardato, si fermarono a far merenda, la mezzadra gli portò pane e vino e quattro robiole una sopra l'altra, e loro le intaccarono tutte per trovare la più saporita ma poi finirono per piluccare a tutt'e quattro. Noialtri per la sorpresa avevamo smesso di far corbe per chiocce nella stalla e sull'uscio della cucina stavamo a guardarli, con gli occhi fuori della testa. Appena ripartiti sulla loro bella domatrice, Tobia si piantò in mezzo all'aia e si mise a bestemmiare un'esagerazione, che dopo un po' io gli andai via da vicino e la padrona andò a scrollarlo per una spalla: - Basta, Tobia, - gli disse, - non ti piglia l'onta?
- Ah, io ho bisogno di farmi insegnar l'onta dalla donna!
- Sii un po' cristiano, guardati ogni tanto un po' indietro. Bestemmi che fai schifo perché il padrone viene a trovarti una volta ogni morte di vescovo. Ma girati indietro e guarda quelli della Serra che il loro padrone non ha affari in città e così sotto il grano e sotto l'uve gli sta sui piedi per dei mesi.
E Tobia: - Sentitela che si preoccupa per quelli della Serra. Preoccupati per la tua famiglia, o bagascia, perché tu non sai quanto n'abbiamo bisogno, col padrone che per niente viene su a mangiarci quattro robiole in una volta! - e si rimise giù a bestemmiare, per farla ancora star male.
Dopo cena sentii la padrona fare a sua figlia: - Ce l'hai il velo, Ginotta? Pigliamo la strada e andiamo a pregare noi due a Cappelletto. Se non chiediamo perdono noi per lui, c'è posto che stanotte nostro Signore ci mandi del male a noi o alla campagna.
Tobia era giusto sull'uscio e le fece penare un po' a passare, ma poi si schivò e disse loro dietro: - E' suonata la campana, o due bagasce?
Dopo dei mesi che lavoravo al Pavaglione, arrivò per me la volta buona di calare ad Alba. Tanta la voglia che n'avevo che quella notte la passai mezza bianca, e bastò a svegliarmi al romper del giorno il rumore che fece Tobia per aprire il cassetto del carro e metterci dentro il pane e il lardo e il pintone di vino da mangiare e bere laggiù in città.
Scendevamo, Tobia dietro al freno e io davanti alla bestia, che a ogni svolta m'aspettavo di veder Alba distesa sotto i miei occhi come una carta tutta colorata. A San Benedetto si parlava sempre d'Alba quando si voleva parlare di città, e chi non n'aveva mai viste e voleva figurarsene una cercava di figurarsi Alba. Bene, stavolta l'avrei vista e ci avrei camminato dentro, e quella fosse pur stata la prima e l'ultima volta, io avrei poi sempre potuto entrare in ogni discorso su Alba e mai più provare invidia per chi l'aveva vista e si dava delle arie a discorrerne. E mentre che ero tanto lontano da casa che vedevo Alba, a casa in un certo senso ci tornavo, perché mio fratello Emilio stava in Alba.
Non c'era nessun bisogno che Tobia mi gridasse nelle orecchie di guardar Alba perché io me n'ero già riempiti gli occhi e per l'effetto lasciai la bestia e passai sul ciglio della strada a guardar meglio. Mi stampai nella testa i campanili e le torri e lo spesso delle case, e poi il ponte e il fiume, la più gran acqua che io abbia mai vista, ma così distante nella piana che potevo soltanto immaginarmi il rumore delle sue correnti; quel fiume Tanaro dove, a sentir contare, tanti della nostra razza langhetta si sono gettati a finirla.
Tobia mi prese per le spalle come per puntarmi e mi disse: - Lo vedi quel gran palazzo col giardino davanti e tutti quegli archi al primo piano? E là dentro che tuo fratello studia da prete.
Io adesso avevo la febbre d'arrivare, ma ce ne volle prima che i ferri della nostra bestia facessero le scintille sui selciati d'Alba, nell'aria bassa.
Era mattino buon'ora, ma vedevo già tanta di quella gente in giro, uomini donne bambini e perfino soldati, da non capacitarmi che ciascuno avesse un nome e cognome come su da noi. Guardavo tutto e tutti, per non perdere niente, e mi faceva strano che nessuno guardasse me. Ma c'era una cosa che non mi riusciva di fare, ed era guardare in faccia i ragazzi d'Alba che all'occhio mi sembravano della mia età; li vedevo avvicinarsi ma nell'incrociarli era più forte di me, dovevo chinare gli occhi, per poi voltarmi a guardarli una volta passati. Finché mi venne una rabbia e quasi come un odio, nel guardarli alle spalle dicevo dentro di me: "Ah, se fossimo sulla langa, come vi concio uno per uno, fossimo sul mio terreno". Roba da far pena, ma allora ero forgiato così.
Andammo dove stava il nostro padrone: una gran bella casa isolata in un viale, per andargli nel cortile si passa sotto un arco.
Nel mezzo del cortile stavano già in riga due carri, erano i mezzadri dell'altre due cascine di quel padrone e mentre io curvavo il carro salutarono Tobia: - Ehi del Pavaglione, - e Tobia: - Ehi della Commanda, ehi del Rombone, - ma tutt'e tre sottovoce, perché sapevano che il padrone dormiva ancora. Fermai il carro alla mira degli altri e poi diedi una spiata agli altri servitori. Arrangiavano il carico e il giogo alle bestie, tanto che io pensai che mi toccasse far lo stesso e senza chiedere a Tobia mi ci misi. Ma Tobia girò gli occhi e mi fece: - Non toccar niente, tanto non cambia niente. Ce l'ha amara con me e se gli portassi dell'oro dice che è ottone.
Cominciò a uscire sul ballatoio una ragazza, doveva essere la servente del padrone, fece due volte il ballatoio su e giù guardandoci con superbia e poi voltò la testa e tornò in casa. Tobia disse: - Quella bagascia. Guarda come tratta. E' dei nostri, io so che è nata e cresciuta in un letamaio a Benevello, ma dopo due anni che fa la servente in Alba guarda come tratta.
Poi dopo uscì il padrone, aveva addosso una lunga roba gialla che io non ho mai visto portare a degli uomini, e aveva la faccia del mal risvegliato; senza piegarsi guardò giù ai carri e subito gridò: - Coglione d'un Tobia, è così che si fa un carico? E quella bestia come l'hai attaccata? O assassino, credi che le bestie siano solo tue?
A me mi mancò il fiato, guardai per traverso a Tobia e gli vidi la testa sul petto e le mascelle muoversi come se si masticasse la lingua. Vidi che anche gli altri mezzadri, che non erano stati toccati, stavano anche loro a testa bassa. Il padrone scese così come si trovava in cortile e si mise a interrogare i suoi mezzadri in un angolo, e anche lì Tobia era il più strapazzato. Poi i mezzadri tornarono da noi, ci fecero girare le bestie perché dovevamo andare a scaricare a un mulino che aveva detto il padrone.
Dopo, Tobia era allegro e come ansioso che stessi allegro anch'io, ma io non mi sentivo di alzargli gli occhi in faccia, mi domandavo solo se su al Pavaglione lo sapevano come il padrone trattava il loro Tobia giù in Alba.
Posammo carro e bestia a uno stallaggio dove Tobia era conosciuto e mangiammo su uno scalino, senza parlare come i frati; io mandavo giù la roba senza sentirci il gusto, forza che volevo correre a vedere Emilio nel suo nuovo stato, Tobia capì e mi diede la larga, a ritrovarci lì per quattr'ore.
- Per dove piglio per andare al seminario?
- Fatti insegnare mentre vai. E non aver vergogna a parlare coi cittadini. Sono bestie come noi.
Partii, per strada chiesi a due del seminario, ciascuno m'insegnò solo un pezzo, ma il terzo non fece che voltarsi e puntare il dito a un palazzo che deve essere una vera antichità, proprio lì in faccia.
Entrai nell'androne: c'era in fondo un portone ma chiuso e a sinistra una portina mezz'aperta. Mi sporsi e non mi sbagliai che era il parlatorio. C'erano cerchi di gente attorno a un ragazzo vestito di nero o a un giovane già coi bottoni rossi, e sulle panche contro i muri della gente seduta che aspettava e si guardava le scarpe impolverate. Parlavano tutti basso e nessuno rideva, come se visitassero dei malati. Non uno di tutta quella gente aveva la parlata delle langhe.
Mi venne davanti un vecchio zoppo e mi domandò chi cercavo.
- Io ho qui mio fratello a studiare. Si chiama Braida Emilio -. Volevo aggiungerci che veniva da San Benedetto, ma quel vecchio doveva già saperne abbastanza perché mi girò la schiena e uscì da una portina in fondo.
Emilio sarebbe entrato di là, e io mossi i piedi sul pavimento come se dovessi aspettarmi un urto e non mi sentissi ben piantato. Poi lui entrò: portava lo stesso vestito nero che era partito ed era in faccia come se il sole per lui non s'alzasse più. Ci baciammo sulle guance e Emilio disse subito qualcosa che io non afferrai, tutto preso com'ero dalla novità della sua voce, che era ben cambiata.
- Sono calato ad Alba col mio padrone, - gli dissi: - Lo saprai che non sono più a casa.
- Me l'hanno scritto subito.
- A te ti scrivono? E cosa ti dicono? Hai una lettera da farmi vedere?
- E' già un po' che non mi scrivono più. Ma ho scritto io a loro e se tardano a rispondermi faccio una lettera al parroco.
- Allora mettici anche che m'hai visto e che sto bene. La volta che torno avrò piacere che mi mostri la lettera da casa.
Da dentro veniva ogni minuto una scampanellata e a tutte Emilio drizzava le orecchie.
- Però sei ben pallido, Emilio.
- Usciamo poco o niente da qui dentro -. Poi la voce gli si fece anche più fina: - Agostino, hai del denaro appresso?
Avevo dieci soldi e li tirai fuori: - Li vuoi? Tanto io non sono buono che a perderli al nove.
- Ho fame, Agostino. Esci un momento con quei soldi e comprami qualcosa da mangiare.
- Cosa ti compero? - Mi ricordavo sì di quello che gli piaceva mangiare a Emilio, ma ai tempi di casa, adesso mi sembrava di dovergli domandare anche come respirasse.
- Comprami qualunque cosa.
Io subito non mi mossi, stavo coi miei dieci soldi in mano e negli occhi di mio fratello vedevo come in uno specchio me e lui al paese, un dopopranzo di festa, che pescavamo con le mani i gamberi in Belbo. - Comprami qualcosa che mi rallegri, - e mi toccò sul braccio per farmi svegliare e partire. E quando io ero già alla porta, mi corse dietro per dirmi di comprargli delle mele in composta.
A quella bottega che c'è sul mercato dei piatti gli comprai per quattro soldi di mele in composta e per sei di pesci marinati. Tornai coi due pacchetti, ma la portina del parlatorio era chiusa e dietro non c'era un filo di rumore. Mi prese un affanno, che mi fece bussare un po' forte, ma passò un bel cinque minuti prima che sentissi il passo dello zoppo. Aprì e mi disse: - Son già tutti in cappella. Cos'hai lì in mano?
- Roba mangiativa che m'ha chiesto mio fratello.
- Dammi qua che gliela do io, - e io buonuomo mi trovai con le mani vuote e il legno della porta contro il naso.
Dovetti decidermi a uscire, una volta fuori mi girai a guardare da sotto in su la facciata del seminario, e feci anche qualche passo in un vicolo dove il fabbricato continuava, come se cercassi un pertugio che mi lasciasse rivedere mio fratello: davanti alla pietra tutta cieca sentii il bisogno di chiamar forte nostra madre, per tutt'e due.
Tornavo allo stallaggio, non avevo nessuna idea dell'ora, di gente in giro ce n'era solo più metà, e s'era levato un vento, ma che sapeva d'erba marcita e di rane. Mi ritrovai allo stallaggio non so come, Tobia non c'era ancora e questo mi diede un batticuore che per farmelo passare andai dalla bestia a posarle un braccio sulla giogaia. Avevo voglia del Pavaglione, lo sentivo casa mia, ed ero sicuro che anche Emilio sarebbe stato ben contento d'esserci.
Poi tornò Tobia, reggendo la sporta della sua donna gonfia di roba, e andammo su.
Non capitò più niente di straordinario, se non che si sposò Ginotta. Noialtri ci sognavamo quella data perché avremmo una buona volta allungato le gambe sotto una tavola che meritava. Come tutti su quella langa, io facevo Amabile l'uomo di Ginotta. Difatti i suoi di lei avevano dato licenza al sensale di quello d'Agliano e solo più il sensale d'Amabile si faceva vedere al Pavaglione, ma erano le sue ultime visite; era già un po' di feste che dopo messa Amabile accompagnava Ginotta davanti a noi dalla chiesa fino al bivio del Pavaglione e la sera che noi tornavamo da Cappelletto da veder giocare i forti al pallone Ginotta non mancava mai di domandarci se Amabile aveva vinto o perso, perché Amabile era il capo d'una delle quadriglie.
Non capitò più niente di straordinario, se non che si sposò Ginotta. Noialtri ci sognavamo quella data perché avremmo una buona volta allungato le gambe sotto una tavola che meritava. Come tutti su quella langa, io facevo Amabile l'uomo di Ginotta. Difatti i suoi di lei avevano dato licenza al sensale di quello d'Agliano e solo più il sensale d'Amabile si faceva vedere al Pavaglione, ma erano le sue ultime visite; era già un po' di feste che dopo messa Amabile accompagnava Ginotta davanti a noi dalla chiesa fino al bivio del Pavaglione e la sera che noi tornavamo da Cappelletto da veder giocare i forti al pallone Ginotta non mancava mai di domandarci se Amabile aveva vinto o perso, perché Amabile era il capo d'una delle quadriglie.
Si trattava solo più che il sensale venisse su coi suoi d'Amabile a fissare la data dello sposalizio e il giorno da scendere ad Alba per comperare a Ginotta le scarpe e la verga e poi passare dal padrone a dargli l'annunzio e vedere se faceva il regalo. Invece un sabato sera, che Tobia aveva lasciato il lume acceso per Ginotta che doveva scriversi l'elenco del fardello perché sua madre n'avesse ricevuta, quel sabato sera arrivò il sensale da solo e che nessuno l'aspettava.
Tobia disse: - Qui c'è del pane mal masticato, e senza dargli da sedersi fece parlare subito il sensale.
- Rabino, non pigliatevela, ma il mio uomo vuole che gli aggiungiate un marengo.
Ci aspettavamo tutti la furia di Tobia e invece lui trovò una voce ragionativa e parlò come un avvocato. Disse: - Ha considerato Amabile che lui è particolare mentre io sono solo un mezzadro? Eppure gli do mia figlia, sana, tutt'altro che brutta e ancora così com'è uscita da sua madre, e le ho fatto quattro marenghi di dote. Amabile cosa può pretendere di più? Sentiamo.
- Dice che voi come mezzadro siete grosso e che invece lui come particolare ha appena un fazzoletto di terra e non della meglio che ci sia.
Tobia s'era preso le mascelle tra le mani e faceva suonare il suo pelo bianco, ma prima che trovasse da rispondere si ficcò in mezzo Ginotta e io non l'avevo mai vista tanto decisa.
- Parlatemi a me, - disse al sensale: - Amabile è proprio fisso su quel marengo in più?
- Da come m'ha parlato sì.
- Proprio Amabile che si fissa su un marengo, lui che al pallone rischia uno scudo in una partita ai cinque giochi! Ebbene, Amabile quel marengo in più non lo vale. Mi rincresce per voi, per la strada che avete fatto e le parole che avete spese, mi rincresce che dovete perdere il pastrano che v'eravate meritato, ma il vostro Amabile quel marengo in più non lo vale. Per me il contratto è rotto.
A quel sensale vennero le lacrime agli occhi, stette un po' con la bocca aperta e le mani giunte a guardarci in faccia uno dopo l'altro, perfino me che non c'entravo, e in quel mentre Ginotta portò fuori sua madre, a confidarsi. Poi al sensale ritornò la parola, e sempre a mani giunte si raccomandò a Tobia, che n'aveva parlato bene in giro fin dal primo giorno che Tobia era venuto mezzadro al Pavaglione, che adesso senza potercene niente era in pericolo di fare una figura che gli avrebbe rovinato tutte le senserie, che doveva trattarsi solamente d'una sera storta, perché Ginotta era la ragazza col più bel naturale che aveva mai trattata.
Ma Tobia gli disse: - L'avete sentita mia figlia. E come volete che io le vada contro, a una figlia di tanta coscienza che non permette che suo padre getti via i soldi per lei?
Basta, la menarono lunga, con dei ragionamenti che adesso io non saprei rifare, ma quel sensale con Tobia non poté dirla, e quando partì piangeva come un bambino, proprio senza più nessuna speranza. E difatti, uscito lui, rientrò Ginotta e disse a suo padre: - Mi son messa d'accordo con mia madre. Se non hai niente in contrario, manda a chiamare il sensale che parla a nome di quell'uomo d'Agliano.
Andai io a fargli la commissione, fino ai Badellini, ma la sera che eravamo rimasti d'accordo tardava ad arrivare, finché sentimmo dei botti e delle grida d'aiuto giù sulla strada di Mango, mentre il nostro cane faceva delle voci nere e accendeva tutti i suoi soci dagli altri pagliai. Noi uomini scendemmo al soccorso, ma quando saltammo sulla strada di Mango c'era solo più il sensale, tutto storto per la battuta e le mani larghe sulla faccia.
- Sputo sangue, - ci disse: - E' stata la gente d'Amabile, per la gelosia. Ricordatevi poi, Tobia, di cos'ho passato per il bene di vostra figlia.
Ma Tobia gli disse solo che un'altra volta passasse da Mompiano.
Combinarono al galoppo e bene per Tobia: quel monferrino ci stava a quattro marenghi e in quanto alla sposa si fidava talmente del sensale e della sua descrizione che per veder Ginotta aspettava d'avercela accanto davanti al prete. Tobia invece spese due giorni per andare a vedere il bene di suo genero e tornò dicendo che la terra era poca ma tutta messa a viti nuove e lavorata da maestro.
Mancavano due giorni allo sposalizio, e la padrona cominciò a far da mangiare. Veramente lei voleva che Tobia chiamasse una cuciniera di Treiso che era tanto nominata per i pranzi di sposi, ma Tobia disse che di soldi gliene andavano già fin troppi a far le cose ordinarie. Il pranzo quindi lo prepararono la padrona e Ginotta; la vigilia non ci lasciarono più entrare in cucina, per paura che toccassimo e per conservar la sorpresa; quel giorno mangiammo sotto il portico nelle scodelle che ci portò fuori Ginotta tirandosi con un piede l'uscio dietro. Ma noi tornando dalla terra avevamo fatto il giro della casa, alla cerca di cos'aveva buttato via la padrona: avevamo trovato budelle e piume di gallina e c'eravamo rallegrati.
Si sposarono a Trezzo agli ultimi d'ottobre. Lo sposo non aveva più sua madre ed era venuto con suo padre, suo fratello e un suo zio sul biroccio del sensale. Facevano tutti abbastanza bella figura.
Della parte di Tobia era venuta più gente di quel che m'aspettassi: un suo fratello e due sue sorelle cogli uomini e i bambini, portarono a Ginotta i loro regali dentro delle scatole da scarpe. Io avevo paura, con un affanno che mi guastò la cerimonia giù a Trezzo, paura che con tutta quella gente invitata non ci fosse a tavola un posto anche per me, che non ero parente ma solo servitore, e mi ficcassero in un buco dove potevo anche essere qualche volta dimenticato; invece si strinsero e mi fecero sedere a tavola, in mezzo ai bambini.
Prima d'allora non avevo mai mangiato un pranzo così e anche oggi farei una buona giornata se m'invitassero a uno uguale. La padrona non mi faceva torto e tutte le volte che mi calava roba nel piatto mi diceva da sopra: - Mangia, Agostino, mangia, ragazzo. Tu che non sei parente non hai l'obbligo di star attento ai loro discorsi, tu mangia solo e non perdere tempo -. E difatti non ci stavo attento, ma dopo un po', che eravamo ben avanti nel pranzo, sentii la voce di Tobia calare calare e poi rompersi finché Tobia pianse. Noi restammo tutti coi denti fermi e la padrona gli domandò cos'aveva visto.
- Niente, - disse la sorella di Tobia la più vecchia, - è solo il vino che è sceso fino a toccargli il cuore.
- Si sì, - disse l'altra sorella, - dev'essere proprio il vino che gli è andato per la vita.
- Cosa possiamo farci? Cosa vuoi che ti facciamo, o Tobia?
- Niente del tutto, lasciarlo da lui solo, - disse sua sorella la prima, e difatti Tobia, nel silenzio, si ripigliò, ma non diede nessuna spiegazione.
C'erano delle volte che dovevo fermarmi un momento di mangiare e allora mi guardavo Ginotta accanto al suo uomo fresco fresco e quantunque fossi pieno di cibo e di vino avevo ben presente che tra qualche ora Ginotta sarebbe partita per sempre e per me il Pavaglione sarebbe poi diventato più brutto di prima, ma proprio il cibo e il vino non mi lasciavano prendere la cosa sul triste.
Era destino che Tobia dovesse disturbarci in quella bella tavolata. A un bel momento disse forte che doveva uscire a far acqua e s'alzò e andò fuori facendoci spostare tutti. Non era passato un minuto che sentimmo un suo grido e appena potemmo districarci dalle sedie e gli uni dagli altri corremmo sull'aia; ma lo trovammo e raccogliemmo in fondo alla riva. Era andato sull'orlo a far acqua e siccome ne aveva più nella testa che nei piedi era cascato giù come un palo. Sembrava che si fosse rotto il naso, aveva la faccia incrostata di sangue e di terra bagnata da lui medesimo. Sua sorella la più vecchia lo toccò sulla fronte e disse che aveva già la febbre. Lo coricammo e tornammo a finir di mangiare.
Ci alzammo che la campana di Cappelletto dava vespro, ed eravamo tutti pesanti più del piombo. Ginotta voleva a tutt'i costi aiutare sua madre a sparecchiare, ma la padrona le disse: - Ci mancherebbe altro! Ma tu non sai che giorno è questo per te. E' il primo e ultimo giorno bello della tua vita, o povera Ginotta. Neanche il giorno che avrai il tuo primo bambino sarà più bello come questo.
Fuori, lo sposo e i suoi erano già sul biroccio, duri come se fossero offesi ma invece era per resistere all'effetto del vino, guardavano avanti la strada che dovevano fare e a noi davano la schiena. Io portai fuori il fardello di Ginotta e lo posai sull'asse dietro del biroccio, ma legarlo volle legarlo Jano, e siccome per il vino gli ballavano gli occhi e le mani fece una legatura che quelli prima di metà strada saran dovuti scendere a rifarla.
Ginotta era salita a baciare suo padre nel letto, io facevo conto che sua madre l'avesse accompagnata di sopra e così entrai franco in cucina per pigliarmi dei pezzi di carne avanzati e andarli a nascondere nel paglione e mangiarmeli poi nella notte o alla mattina Ma la padrona era rimasta di sotto, s'era inginocchiata su una sedia e pregava con la fronte contro il muro, e allora io non me la sentii più e tornai fuori.
Quando Ginotta fu sul biroccio in mezzo a quei quattro si voltò e ci gridò: - Vi rendete conto che me ne vado? E adesso come farete senza di me?
Jano rise: - Parti tranquilla che faremo lo stesso.
Il sensale diede al cavallo e Ginotta che non se l'aspettava lo scrollo la sbatté giù sul sedile, ma si rialzò mentre già andavano e gridò a sua madre: - Se io non potessi, vieni tu a trovarmi ad Agliano! Almeno una volta all'anno vienimi a trovare!
La vita ti dà addosso con dei castighi: io per aver tardato ad andare in licenza non ho più visto vivo mio padre.
La vita ti dà addosso con dei castighi: io per aver tardato ad andare in licenza non ho più visto vivo mio padre.
Già più d'una volta Tobia m'aveva detto che era tempo di prendermi la mia prima licenza, ma io non l'avevo ancora ascoltato. Pensiamo se non avevo voglia di tornarmene qualche giorno a casa, ma volevo anche farmi desiderare dai miei lassù, come li avevo visti mettersi a desiderare Stefano quando fu un bel po' che era soldato e a casa in licenza non veniva mai. E così mi facevo forza contro la voglia di casa mia e per ogni giorno che potevo essere a casa e invece resistevo al Pavaglione mi sembrava di farmi un merito. M'aiutava a tener duro la stagione, che era inverno, e se Dio voleva il lavoro non ammazzava più e poi si passava quasi tutto il tempo al caldo nella stalla, tanto che ci faceva basta il mangiare che era ancora più scarso che in tutte le altre epoche. Finché la padrona mi disse quasi da arrabbiata che non credeva che io fossi un figlio così, che non sentivo il dovere di farmi rivedere dalla mia gente dopo un anno che ero lontano, e allora le promisi che andavo. Era talmente sicuro che l'indomani partivo, che la sera la padrona mi disse: - Domani che li vedi, di' ai tuoi che questo Natale non t'abbiamo regalato i calzoni perché sai le spese che abbiamo fatto per la nostra Ginotta, ma il Natale che viene te li portiamo senza fallo -. Ma nella notte nevicò di nuovo, e non potevo squarciare un ginocchio di neve fino a San Benedetto; quel giorno Tobia mi mandò sul tetto, a sgravarlo dalla neve.
Poi venne la festa di noi servitori. I più vecchi calarono ad Alba e con loro andò anche qualcuno della mia età; io avrei voluto aggiungermi a loro, ma Tobia non mi lasciò, con la scusa che Alba era un posto pieno di pericoli per i servitori giovani in festa, c'erano dei droganti che li aspettavano e li intrattenevano apposta per piumarli dei pochi soldi a tutt'i giochi, e poi ad Alba finiva sempre che i più vecchi facevan prendere ai più giovani il vizio delle donne portandoli in certe case apposta. Invece fu contento che andassi alla festa nell'osteria di Manera che c'eravamo combinata noi che non eravamo scesi ad Alba. Ci fermammo tutto il dopopranzo e la sera, di servitori ce n'era venuti fin da Campetto, c'era poco da mangiare e molto da bere, io ci presi la mia prima sbornia da uomo, e ballammo anche, uomini con uomini, con la musica d'un suonatore di Borgomale per il quale mettemmo cinque soldi a testa. Fu proprio quel giorno lì che capitò la disgrazia a mio padre.
Tre giorni dopo, mi trovavo nel rittano sotto la casa a far fascine, che era il mio ultimo lavoro prima della licenza. Venne Tobia e mi chiamò da sulla strada, ma la notizia non me la diede che quando fummo sull'aia. Mentre ero giù nel rittano era passato al Pavaglione un olearo della Liguria che veniva dai miei posti e andava a Mango al mercato; a San Benedetto mia madre gli aveva comperato l'olio a patto che lungo la strada per Mango passasse al Pavaglione e le facesse una commissione: dire a me o al padrone che mio padre era finito nel pozzo per disgrazia, l'avevano tirato su in tempo ma stava male e perciò che io andassi subito a casa.
- Non lo vedo più, - dissi subito, ed era la prima volta che avevo quella campana negli orecchi.
- Non star lì a cabalizzare se lo vedi ancora o se non lo vedi più, ma piglia subito la strada.
- Voi, Tobia, lo sapete che è già morto ma non me lo volete dire.
- Che mi crollino gli occhi se t'ho cambiato una sola parola di quell'olearo. Non star lì a cabalizzare, ma piglia subito la strada, - e mi diede tre marenghi sulla mia annata. La padrona mi disse: - E per strada prega nostro Signore che ti faccia la grazia di tuo padre. Io di qui prego anch'io -. Aveva già pronto in mano pane e lardo e lei stessa me lo mise in seno. M'accompagnarono tutti al cancello, uno dietro l'altro che sembrava già quella una sepoltura.
Un viaggio così non glielo auguro a nessuno. Ci vogliono quattro ore e ce ne misi quasi sei; ma è che quando mi convincevo a sperare allora marciavo tanto forte che mi sfiancavo e dovevo lasciarmi andar giù sul ciglio della strada, ed era lì da fermo che mi ripigliava la disperazione e mi toglieva quasi la forza di rialzarmi e rincamminarmi. Pensavo alla vita che aveva fatto mio padre, a tante parole e gesti suoi, a Emilio se era stato avvisato come me e se era anche lui per strada, a nostra madre e Stefano che loro sapevano già tutto, piangevo e gridavo a mio padre che forse non succedeva se c'ero io a casa, invece che m'aveva mandato a servir lontano.
Arrivai al paese al primo scuro, vidi dall'alto la nostra casa giù verso Belbo, mi sembrò che portasse sul tetto tutto il peso del cielo, e mi diede un colpo al cuore vedere la luce alla finestra dei nostri, una luce che non poteva che essere quella di quattro candele.
Difatti non l'ho più visto vivo, e neanche Emilio, quantunque fosse arrivato un paio d'ore prima di me, lui aveva trovato un biroccio che l'aveva portato da Serravalle fino al passo della Bossola.
Restai un po' solo con mio padre e poi scesi. Domandai a mia madre se aveva da parte i soldi per la sepoltura, ma lei mi disse che non n'aveva neanche per far cantare il prete e allora misi sulla tavola i miei tre marenghi. Poi Stefano mi portò al pozzo e mi spiegò tutto com'era capitato: nostra madre gli aveva detto di tirarle un secchio d'acqua e lui s'era sporto a scrollar la catena che per il gelo s'era incantata. Gli scivolò un piede sul pietrone e per il peso della testa era caduto dentro. Era stato Stefano a tirarlo su e portarlo in casa, sembrava che si fosse fatto poco, invece lo spavento gli aveva dato sul cuore, il medico Aguzzi non s'era fidato a salassarlo e poi s'era aggiunta una polmonite delle più secche. Stefano andò poi a prendere una lanterna nella stalla e a quel chiaro m'insegnò il raschio dello zoccolo di nostro padre sulla pietra; vederlo m'empì di spavento e di furore, come se fosse il segno che lascia il diavolo.
Fui contento, con tutto che ero stanco, ma per togliermi da quel dolore così fisso, che mia madre mi mandasse ad avvisare i nostri parenti della sepoltura. Io facevo il giro di Murazzano e Buonvicino, mentre Stefano era già partito per Mombarcaro, Monesiglio e Sale; in casa con nostra madre si fermava Emilio, lui avrebbe visto a vestirlo e incassarlo. Del resto era lui, il più debole, che mostrava più forza: forse ce l'aveva sempre avuta in fondo all'anima, o forse la stava mettendo per via di quello che gli insegnavano laggiù in seminario. Da sulla porta mia madre mi disse: - Tu, Agostino, sei quello che l'ha visto meno di tutti. Cerca di tornare presto dal tuo giro, che non sia già chiuso -. Io le dissi: - L'ho visto bene, madre. Anche se quando torno è già chiuso, pazienza. L'ho visto bene.
La mattina della sepoltura faceva sole, e io non sapevo se per questo dovevo rallegrarmi un po' o intristirmi di più per mio padre. Noialtri fratelli eravamo fuori, di buon'ora, a star attenti alle strade per le quali dovevano giungere i nostri parenti. Arrivarono chi prima e chi dopo, tutti con la bestia, e io naturalmente andai incontro a quelli che erano stati avvisati da Stefano. Ma m'interessavano più di tutti i nostri zii di Mombarcaro, perché speravo che avessero portato anche la loro figlia Giulia. Giulia era la più bella e la più ricca delle nostre cugine, quella che aveva l'esistenza più ambiziosa e felice, e la più nominata dalla parentela; io contavo che ci fosse alla sepoltura di mio padre, m'aspettavo da lei una consolazione speciale, e non vederla sul calesse in mezzo ai suoi mi mandò il cuore giù fino ai garretti. Come se non fossi persuaso, invece d'andare a salutare gli altri, seguii dentro casa gli zii Emilia e Annibale e sentii mia madre domandare a sua sorella perché non aveva portato anche Giulia. - Ma come facevo? - rispose zia Emilia: - Lo sai bene che la mia Giulia è a Mondovì a studiare dalle suore.
Ormai erano arrivati tutti, ci avevano baciati sulle guance, dicevano: - Noi ci vediamo sempre solo in queste occasioni, - si sedevano e aspettavano il caffè. Nostra madre glielo passò, dicendo a tutti la stessa cosa: - Eh, che gesto mi son vista, - e poi dovette mandarmi a comperarne per altre due once.
Dalle occhiate e dalle mosse dei parenti si capiva che per loro era come se il tempo non passasse più, mentre a me sembrava che galoppasse; zio Annibale tirò fuori il suo orologio d'argento e domandò come mai la campana non cominciava a suonare la portata. Uscì Emilio a darsene ragione e tornò dicendo che il prete di Costalunga tardava, aveva fatto sapere che lui a piedi non si muoveva e che dovevano mandargli una bestia se lo volevano avere in chiesa. Zio Annibale offrì il suo calesse, ma Emilio disse che era già andato su Canonica e nostra madre benedisse Canonica: - Chi l'avrebbe mai detto all'epoca che ci facevamo la guerra per la censa -. Ma zia Emilia le disse: - Povera Melina, se sapessi come resta facile far la bella figura dei generosi dopo che si è vinto.
Fuori c'era già della gente a bisbigliare e scalpicciare nella neve, attraverso la finestra si vedeva il giallo delle carmelitane, che era la compagnia di nostra madre. Poi dovette essere arrivato Canonica col prete di Costalunga perché suonò la campana di nostro padre.
Quattro uomini alzarono la cassa, ci si arrembarono sotto e ce lo portarono fuori, noi tutti dietro a piangere, e chi piangeva più forte era Stefano, col fazzoletto sulla bocca. Emilio lui non piangeva, perché doveva recitare il rosario andando, e gli sentivo la voce abbastanza ferma.
In chiesa si spicciarono perché dovevano pensare a messa ultima, c'erano i chierichetti che quando i tre preti non avevano bisogno di loro si cimentavano l'un l'altro, si ficcavano le dita nel naso e stavano per dei minuti voltati verso di noi per veder bene i nostri parenti di fuori. L'ho fatto anch'io, quand'ero ben lontano dall'essere in prima fila dietro una cassa.
Quando uscimmo di chiesa il tempo s'era girato: il sole era andato a nascondersi e al suo posto c'era il vento; un'ariaccia che arruffava la coperta sulla cassa e una volta che fummo fuori del paese spense i ceri alle carmelitane. Ci fermammo perché potessero riaccenderli, ma quell'aria glieli smorzò di nuovo e allora andammo avanti così. Per le undici era sotterrato e io ero invecchiato di dieci anni. Tornammo pian piano; sull'aia che ci aspettava c'era nostra madre con zia Emilia che la teneva per la vita. Ci disse: - Avete già finito? Gli avete fatto tutto bene a quel pover'uomo? Dopopranzo vado a vedere.
Per pranzo c'era tonno, sardine e olive, gallina e il suo brodo, doveva morire nostro padre per metterci nell'obbligo di fare un pranzo così. Se sul principio si stette ancora zitti è perché avevano tutti fame, ma poi si scaldarono a parlare; parlavano degli affari che avevano fatto o che avevano in mente di fare, di prezzi e di mediazioni, a un certo punto zio Annibale disse forte che lui nella vallata di Bormida aveva dei crediti per cinquantamila lire, zia Emilia disse subito che non era vero niente, ma lui disse più forte ancora: - Sì invece, e ce n'avrò fin di più! - Anche noi ci mischiammo ai loro discorsi, anche noi domandavamo e rispondevamo, e quando loro ridevano arrivavamo a sorridere. Uno alla volta, tutti domandarono a Emilio un bricco di cose sul seminario d'Alba, ma a me nessuno chiese niente, perché io ero a servire, l'unico di tutta la parentela che fosse a servire, e la cosa imbarazzava anche loro.
Ci levammo da tavola che per la stagione era già tardi, il cielo metteva freddo nel filo della schiena a solo guardarlo da dietro i vetri, e si leggeva in faccia a tutti i nostri parenti il disgusto di dover far strada fino a casa per quelle langhe crude. Nostra madre voleva rifare il giro del caffè, ma non la lasciarono e dopo averci baciati uno per uno sulle guance montarono sui birocci. L'ultima fu zia Emilia, che disse a noi fratelli: - Tenete da conto vostra madre. Accuditela e più che tutto fatela mangiare. E se lei non vuole e dice che non si sente, voi sforzatela, come alle oche -. Per lei era una parola, che per essere padrona di censa forno e macello aveva in tasca tutto Mombarcaro e a forza di mangiar bene aveva il collo del color del prosciutto.
Noi alla sera cenammo a polenta e cotognata. Poi Stefano disse come un bambino che si sentiva male, si mise a letto e nostra madre salì a curarlo. Io invece uscii nel freddo, arrivai al camposanto e mi misi ad andar su e giù lungo il muretto come se facessi un po' di compagnia a mio padre, poi sentii dei passi nella neve; era Emilio che veniva con la stessa mia ispirazione, Ci gettammo l'uno incontro all'altro e ci piangemmo sulla spalla.
Se cerco qualche fatto che possa dare un quadro di mio padre e del nostro sangue, la prima cosa che mi viene in mente è come ha fatto a conoscere e sposare nostra madre; ma bisognerebbe sentirlo contare da Netino, come ce l'ha contato a me e a Emilio l'ultima volta che fummo dai nostri parenti di Monesiglio per la festa di san Biagio.
Verso i vent'anni mio padre era stato un bel po' via da casa, a Monesiglio, a fare il garzone da suo zio Pietro che allora aveva la locanda sulla piazza. Ci stette quasi due anni, finché dovette tornare a far andare la terra al posto di suo fratello che partiva soldato. Però lui voleva portarsi a casa una donna di Monesiglio o lì intorno, perché quando era partito in tutto San Benedetto non ce n'era una che gli andasse ed era sicuro che in quei due anni non era spuntata la buona. E così gli ultimi mesi a Monesiglio li passò a cercarsi la sua, batteva tutte le case dove si vegliava e non perdeva il più piccolo ballo. Ma non trovava, perché era diffizioso, almeno così diceva Netino, il figlio di Pietro; lui e mio padre avevano la confidenza di due gemelli.
Netino disse un giorno a mio padre, che erano seduti sulla panca fuori della locanda: - Stanotte ho sentito dare i due botti e tu non eri ancora tornato Dove sei finito?
- A ballare ai Colombi. Me ne sono andato via coi suonatori.
- E hai trovato?
- Niente.
- Ho bell'e visto che te ne torni a San Benedetto con quel nodo ancora da fare.
- Non avessi cercato, volessi la regina Taitù, - disse mio padre.
- Diffizioso sei diffizioso.
- Ma qui è questione di mescolare il sangue. Tu fai presto a dire diffizioso.
Netino con più niente da dire si mise a guardare le case in faccia, poi di colpo fece: - Melina! - come se avesse trovato un marengo in mezzo al fango.
- Che Melina? Melina di Biestro?
- Proprio Melina di Biestro. Cosa vai a cercare per mezza val di Bormida quando hai solo da traversare la piazza? Melina, com'è che non c'è mai venuta in mente?
Era una figlia di quei Biestro che negoziavano forte nelle robiole, stava con suo fratello dall'altra parte della piazza, e non gli era mai venuta in mente forse perché non l'avevano mai sentita nominare da nessun uomo. Era grande come mio padre, un po' carabiniera, vestita sempre di nero fin da bambina, mai vista su un ballo, di chiesa ma senza perderci le bave; aveva la particolarità che montava a cavallo come un uomo, sempre a cavallo girava la val di Bormida per il suo commercio e allora si metteva i gambali da soldato e per questo fatto dei gambali c'era qualche brava gente di Monesiglio che la giudicava una balorda.
- Allora la vuoi? - disse Netino.
- Io la prenderei, ma e lei?
- Valla a sentire.
- E se capita a dirmi di no?
- Nessun uomo è mai crepato perché una donna gli ha detto di no.
- Lasciami studiare tutt'oggi e tutta stanotte.
- Macché studiare, stanotte dormi con Melina sotto il cuscino -. E Netino traversò la piazza, diede una spiata alla finestra di Melina e tornò: - Su, che è dentro che incesta le robiole.
- Non sono pronto.
- Dove non sei pronto?
- Non sono pronto con le parole.
- Ma se hai una lingua che non ti ritiri neanche davanti ai preti. Su, datti una cambiata, vestiti da chiesa.
Dài e spingi, mio padre andò, vestito da chiesa ma con la barba della domenica prima, che se ne accorse solo quando davanti a Melina si toccò la faccia con le mani.
Melina era voltata e china che incestava le sue robiole, lui non le diede il tempo di girarsi e le disse tutto attaccato: - Sono Giovanni Braida, il nipote di Pietro Gavarino, e sono entrato a sentire se caso mai volete sposarmi e venire a star con me a San Benedetto.
Lei girò mezza la testa e gli rispose così: - Credete che non lo sappia che siete voi che tutti gli anni fate il carnevale là nel vostro paese di San Benedetto?
- Ma io non burlo per niente, se è questo che volete dire. Per me non è più tempo di carnevale.
- Sentite, Braida, io ho l'anima sversa perché oggi m'è venuta una donna dei Bragioli a portarmi le robiole e gliene ho pagate dodici e adesso ho visto che erano solo undici. Non è il più bel momento per burlare.
- Ma chi è che burla? Io no, e sono qui che aspetto una vostra risposta non da burla.
Allora mia madre si drizzò. Gli venne davanti ed era tanto grande come lui: - Se non burlate, io per adesso non vi dico né di sì né di no, ma vi dico di ripassare quando ci sia mio fratello che è andato a comperare fino a Torresina.
Mio padre tornò alla locanda, si sbarbò ben bene, diede una mano a servire una tavolata di carrettieri, e quando sentì il cavallo di Biestro tornò alla casa in faccia. Biestro gli disse: - Mia sorella Melina m'ha detto della tua domanda. Io come fratello sono contento perché ti conosco per un bravo figlio, con la tua fetta di bene al tuo paese e qui a Monesiglio hai una buona parentela. Però devi andare dai nostri padre e madre e ridichiararti a loro e la risposta che ti dànno loro sarà quella buona. Sai dove stanno.
Stavano nella loro casa dietro i Battuti Neri, dove noi siamo entrati due volte, quando mancò nostra nonna e poi nostro nonno. I due vecchi erano seduti a tavola, ma non stavano contandosela; alla grigia cascava la testa e i rari momenti che la teneva su allora guardava di storto il suo uomo. Mio padre sapeva, come tutti a Monesiglio, perché le cascava la testa, e non c'era niente di straordinario che a quell'ora fosse già piena perché era passato vespro. Il vino gliel'avevano tolto a mia nonna, ma sovente la trovavano ubriaca lo stesso, finché scoprirono che aveva una riserva di fernet nel vaso da notte.
Mio padre rifece la sua domanda, disgenato adesso perché aveva già fatto una prova, e i due vecchi l'ascoltarono fino in fondo. Poi Biestro disse: - E già, e già, e già, - come per non lasciare senza risposta uno che gli avesse parlato del vento e della pioggia. Tirò fuori un toscano e se lo piantò in bocca ma mentre mio padre sfregava uno zolfino la vecchia come una gatta gli strappò il toscano di tra i denti e se lo nascose in grembo, con tutt'e due le mani sopra. Mio nonno bestemmiò una volta, ma poi finì di dirle solamente: - M'hai fatto un gesto dei più belli, bagascia, ti sei presentata a Braida proprio con un gesto dei più belli -. E poi disse a mio padre: - E va bene. Come per le altre nostre tre figlie. Perché io e questa vecchia qui ne abbiamo messe al mondo quattro di figlie, lo saprai, e tre hanno già famiglia, e una ha perfino preso un capitano di mare di Savona, saprai anche questo. Ebbene, tutto come per le altre tre. E' venuta l'ora anche di Melina. Cosa abbiamo fatto per le altre tre lo faremo per Melina, e di cuore.
La vecchia si alzò, tenendosi abbrancata alla tavola come se si vedesse sull'orlo d'una rocca, ma Biestro l'obbligò a rimettersi giù, le domandò cosa voleva alzarsi a fare.
- Il caffè a Braida. Passiamo almeno il caffè a Braida che ci porta via Melina.
- Non hai bisogno d'alzarti tu. Dài una voce alla servente.
Mia nonna diede una voce alla servente e poi disse a mio padre: - Neh che una goccia di fernet nel caffè ti farebbe piacere? - Mio padre era solo da vino e disse di no. - Ma non lo sai che una goccia di fernet nel caffè t'arrangia lo stomaco?
- Già che un uomo come Braida ha bisogno d'arrangiarsi lo stomaco, - disse duro mio nonno, e guardò mio padre per vedere se aveva capito perché la vecchia s'intestava sul fernet. Altro che c'era arrivato mio padre, e aveva paura che per non averla favorita nel fernet non ne avrebbe mai più fatta una bene con sua suocera.
Presero il caffè senza la goccia di fernet e dopo mia nonna si mise a lacrimare e a chiamare: - Melina, Melina, Melina! - finché si alzò di strappo, arrivò alla porta, l'aprì e grido fuori: - La mia Melina si sposa, la mia Melina va via! - e cascò giù contando tutti gli scalini, senza che i due uomini potessero fare un gesto.
Non ci misi un minuto a capire che anche mancato mio padre io non ero più di bisogno a casa. Non ci restava un soldo che è un soldo, eravamo alla mercè della più piccola disgrazia, ci aveva lasciato dalle sei alle sette giornate di terra e un uomo dell'età e della taglia di Stefano poteva lavorarsela tutta da lui solo. Quello che faceva di bisogno a casa nostra erano i sette marenghi l'anno che io guadagnavo laggiù da Tobia, me lo disse chiaro Stefano, con un tono come se lo stupisse che io fossi ancora lì e non avessi già rifatto fagotto. Con Emilio lo stesso, gli disse: - Tu te ne torni in seminario. Noi da qui faremo per te quel poco che possiamo fare, tu laggiù studia di buona voglia per cucirti presto i bottoni neri e prenderti insieme nostra madre nella chiesa che ti daranno.
A Emilio non so, e poi lui avrebbe avuto sempre più poco a che fare con la casa, ma a me questo comandare di Stefano mi mise dentro un affanno, quasi un presentimento che alla fine ci avrei giuntato. Stefano ci aveva già comandati, tra lui e me che ero il secondo c'erano cinque anni di diversità, ma sopra di lui restava sempre nostro padre; adesso il comando tutto nelle sue mani non mi lasciava per niente tranquillo. Non che Stefano avesse dei vizi grossi, ma io di lui, specie dopo che era tornato da soldato, non mi fidavo più, lo vedevo solo più buono per se stesso. O forse m'aveva fatto diventar così diffidente, con tutto che era stata una disgrazia, l'aver visto cosa poteva capitar di male a casa nostra con me lontano. Io avevo sperato, quantunque sapessi bene che non potevano farlo, che con la morte di nostro padre i miei mi facessero fermare a casa per sempre. E dopo avevo sperato che, se lavorare sotto gli altri era il mio destino scritto, mi chiamassero a Mombarcaro i miei zii, che tra censa forno e macello di servitori n'avevano sempre bisogno. Invece il giorno della sepoltura zio Annibale non me ne fece neanche una mezza parola e io non osai incamminargli il discorso. Adesso arrivo a capire che ai parenti si comanda male, se li si vuole tenere almeno un po' da parenti.
Il silenzio di mia madre mi decideva anche di più delle parole di Stefano. Mi guardava da raro e le volte che potevo fissarla negli occhi sembrava dirmi: "Rassegnati a tornartene via perché io mi son già rassegnata a riaverti lontano".
In più avevo il fastidio di Tobia: l'indomani della sepoltura mi domandavo già per quando Tobia mi voleva indietro al Pavaglione; partito com'ero partito per la disgrazia, non eravamo rimasti intesi per niente sul giorno che dovevo tornare. Ed era un pensiero, perché adesso Tobia dovevo tenermelo ben da conto, dopo le illusioni di poter fermarmi a casa oppure d'esser chiamato a Mombarcaro dai miei zii. E così, tra Stefano e Tobia, finii di partirmene il mercoledì. La vigilia stetti tutto il giorno sbattuto sul letto a piangere ogni tanto di rabbia e di desolazione; perché sapevo cosa m'aspettava al Pavaglione, tutto preciso sapevo per giorni mesi e stagioni, e io in quei pochi giorni ch'ero stato di nuovo a casa, malgrado il lutto, avevo rotto l'abitudine fatta al Pavaglione in più d'un anno, come succede di tutte le cose che si fanno per lungo tempo ma senza metterci un'oncia di cuore.
None*
Non c'era nessuno delle parti del Pavaglione che potessi dirmelo amico, ma non avevo neanche dei nemici, salvo forse un balordo che senza avanzar niente da me e soltanto per far lo spiritoso m'aveva attaccato una festa a Manera, ma m'abbrivò solo a parole. Dai primi tempi conoscevo ormai una partita di gente, e quasi tutta l'ho conosciuta dentro i muri del Pavaglione; perché la casa di Tobia era la prima bisca di quei posti. Baldino, il figlio più giovane, aveva la mano santa con le carte, Tobia gli aveva consegnato il mazzo e lui se lo teneva stretto, non l'imprestava nemmeno a Jano, neanche per lasciargli fare una partita di prova con me. Le sere fisse, Baldino tirava fuori il suo mazzo, che nessuno della casa sapeva dove lo nascondesse, e lo mischiava per mezz'ora e senza mai alzar gli occhi, finché alla porta della stalla bussavano i giovani di tutto lì intorno; e dopo due ciance tanto per mascherar la febbre, si cominciavano i tagli al nove. Tobia s'inginocchiava dietro a Baldino e gli studiava il gioco da sopra la spalla, per ridere forte quando Baldino scopriva la sua carta superiore e dargli uno schiaffetto sul collo quando ramazzava la posta.
Io perdevo più o meno in fretta i miei pochi e m'allungavo da parte sulla paglia a guardare un po' il gioco degli altri e un po' la padrona che filava in un angolo. Jano era come me alle carte, che aveva sempre la sfortuna in favore, ma al contrario di me s'illudeva di potersi rifare, e quando aveva perso tutto il suo chiedeva a Baldino che gli imprestasse sul suo guadagno, ma mai una volta che Baldino gli abbia imprestato un soldo, e in questo era spalleggiato da Tobia che ci speculava e conosceva suo figlio più vecchio per una testa perdente.
A proposito del gioco, anche lassù da noi il vizio è incarnito e giocano forte, specie a Murazzano, ma non c'è nessun confronto con le langhe basse, dove in una notte si giocano delle cascine di sessanta giornate e dove spuntano dei giocatori di tanta forza che poi girano il mondo, conosciuti per nome nelle bische d'Alba, d'Asti e di Torino, e che vanno a giocare perfino in Francia. E' capitato a me di vedere un uomo di Lequio che aveva vinto un milione a Montecarlo. S'era fermato al bivio di Manera, tutto vestito di nuovo dal cappello alle scarpe, e teneva la vincita in un pacchetto appeso al dito, un pacchetto come quelli che fanno in Alba per le paste dolci. Tutta la gente intorno a Manera correva a vederlo come un baraccone, lui aspettava che se ne fosse radunata un po', poi alzava il dito e mostrava in giro il pacchetto dei soldi, e diceva: - Tutto quello che vedo posso comprarmelo. O buona gente, posso farvi diventar tutti miei mezzadri -. Era un uomo di Lequio.
Non fosse stato per il gioco, forse non avrei fatto la conoscenza di Mario Bernasca. Era il partitante più forte con Baldino, e il suo avversario naturale, ma glieli lasciava nove sere su dieci, e io che tenevo per lui ci pativo io stesso; lui invece sembrava di no, dopo che aveva perso tutto quello che s'era portato dietro diceva sempre di buon umore: - Tanto non sono miei, sono di quelli che ho piumato lungo questa settimana, - e doveva esser vero perché non perdeva mai meno d'uno scudo e non poteva avercelo se non l'avesse guadagnato al nove o a bassetta da qualche altra parte. E quando aveva ben perso, faceva a Tobia: - Allora, Tobia, stasera ci perdonate il lume, - ma Tobia non rinunciava mai a raccogliere la tassa sul lume, anche quando Baldino aveva avuto una sera d'oro.
Mi ricordo una notte che Bernasca perdeva già più di due scudi e Baldino rideva come fanno le asine quando le portano al maschio. La padrona lasciò di filare, era spaventata per Mario e ontosa che suo figlio vincesse tanto; disse a Bernasca: - Ritirati, Mariolino, che questa è la sera che ti perdi una mesata.
Io guardai Tobia e gli vidi la furia che lo sfisonomiava. Bernasca invece batté le dita sul legno e disse: - Non mi ritiro, voglio vedere se vostro figlio è Lucifero -. Lei gli disse ancora più da comando: - Ritirati, Bernasca, se no un'altra sera in coscienza non ti lascio più entrare.
Allora Tobia saltò su dalla paglia, per un momento credemmo tutti che corresse a darle, invece le tirò solo due o tre nomi e bestemmie in faccia, e allora lei si caricò la sua roba e uscì. Dopo, Tobia ci disse: - Ricordatevi, o giovani, che le donne sono bestie. Non potete acchiapparle perché non hanno la coda, ma se le picchiate in testa sentono -. E tornò a postarsi dietro a Baldino, ma stavolta non gli andò secondo i suoi conti perché Bernasca, uscita così malamente la padrona, per quella sera smise di giocare.
Io mi sentivo tirato verso questo Mario Bernasca, e mi facevo l'idea che anche lui volesse farmi amico, ma ci trovavamo sempre e solo al Pavaglione in mezzo a una partita di gente e non potevamo mai discorrere testa a testa. La prima volta che mi parlò, mi disse: - Me e te siamo due bei stupidi, - e lo fece passandomi davanti per entrare nella stalla a giocare. Un'altra volta mi disse le medesime parole e io ce ne capii tanto come prima, ma non potevo offendermi perché si comprendeva anche lui negli stupidi.
Era della mia leva, ma aveva tutt'un'altra malizia; i suoi l'avevano aggiustato da servitore la prima volta che non aveva ancora undici anni e quindi nessuno n'aveva viste di tutt'i colori come lui. In compagnia Bernasca faceva volentieri la sua storia, e una volta un servitore novello gli domandò che cuore avevano i suoi. - Che cuore hanno i miei? - rispose lui: - Sai cosa m'ha detto mio padre quando io mi lamentai? M'ha detto: "Io t'ho mantenuto fino adesso, adesso se Dio vuole le braccia ti fanno lo stesso servizio che la bocca t'ha fatto fin dal primo giorno. Va' che non mi fai più pena d'un passerotto d'inverno" -. Che odiava suo padre lo diceva piano e forte, e che la più brutta giornata per lui era quando suo padre veniva su da Barbaresco a riscuoter l'annata. La mia padrona, che non voleva sentir parlare così d'un padre, gli disse una volta che se era suo padre non poteva non essere buono, ma lui le rise in faccia e le disse: - Mio padre bisogna assaggiarlo bagnato nell'olio per sentire quant'è buono.
Se Tobia non m'avesse tenuto così a catena, sarei andato qualche giorno a trovarlo dov'era da servitore. Stava passato il pilone del Chiarle, a un'ora da noi, con due vecchi particolari, uomo e donna, in un chiabotto di due stanze e la stalla e un lenzuolo di terra; però faceva andare avanti tutto lui. E così per dei mesi, io che avevo tanta voglia di discorrergli insieme, dovetti contentarmi di sapere che per Mario sia io che lui eravamo due bei stupidi.
La fortuna non cessava d'accompagnare i Rabino: le annate senza essere sante erano buone, e sia le bestie che la famiglia non si risentivano mai un briciolo di male; in quanto al padrone, solo io posso dire la roba che gli ha fatto saltare Tobia. La mia paga dunque non pericolava, ma questo non mi bastava già più; ormai a Tobia io gli rendevo bene e valevo qualcosa di più dei sette marenghi l'anno del patto con mio padre. Adesso che mio padre non c'era più, toccava a me farmi valere e farmi crescere giustamente la paga; a casa avrei mandato sempre sette marenghi, e mi sarei tenuto il resto per fare qualche volta bella figura come Mario Bernasca. Ma ero buonuomo e non trovavo mai il coraggio di parlarne testa a testa con Tobia: avevo il discorso tutto fatto in mente, ma rimandavo sempre, tanto mi sembrava di non sprecar gli anni, persuaso com'ero di dover starci l'eternità al Pavaglione. E poi un giorno o l'altro Tobia doveva di coscienza parlarmene lui. Naturalmente Tobia non incamminò mai questo discorso, invece gliene parlai io, una volta che non ci pensavo neanche, ma glielo dissi dietro la rabbia che m'aveva messo una sua ingiustizia. M'aveva comandato di salar l'acqua alle bestie e io gliel'avevo salata; lui m'uscì fuori che non s'era neanche sognato di comandarmelo e mi strapazzò ben bene. Io mi feci le mie ragioni e già che avevo preso l'abbrivo gliela intonai della paga. Si mise a far dei gridi da una lira l'uno e fortuna che i due figli erano via altrimenti uscivano fuori a picchiarmi come se io stessi scorticando loro padre. Mi gridò che eravamo tutti lì solo per succhiargli il sangue a lui, che non era lecito chiedergli di crescermi la paga solo perché avevo visto passar l'anno senza tempesta né brina, che adesso i merdoni di diciott'anni rompevano i patti fatti da uomini di sessanta, e finì che potevo subito farmi il fagotto e liberargli il paglione per quella sera stessa, che lui aveva già sottomano chi pigliava il mio posto a molto meno e ringraziare.
Dovermene andare su due piedi e cercarmi da dormire come i vagabondi mi spaventò, e mi lasciò incapace di ragionare nel mio interesse; Tobia si accorse d'avermi fatto effetto, si sfreddò e mi disse che saremmo tornati a discuterne, ma solo dopo il grano. E mi lasciò lì in mezzo all'aia, che non avevo combinato niente e forse gli avevo solo dato il mezzo di tenermi più duro.
Mi venne vicino la padrona, che aveva sentito da dentro la casa i nostri sfoghi, e mi disse: - Abbi pazienza, Agostino. Il mio uomo è fatto così: che se gli dici prendi capisce al volo, ma se gli dici dammi non ci sente. Io medesima ne sono alle prove.
- Di voi lo so, - le dissi guardando in terra.
- Ma non sai tutto. Dal giorno che Ginotta m'è andata via, io vi ho addosso tutt'e quattro voi uomini. E ti dico che mi fate perder la pancia, e chissà se la duro.
- Cosa vi sentite?
- Soltanto stanchità per adesso, ma una gran stanchità.
- E voi riposatevi.
- E voi quattro chi vi guarda? Ho necessità che Tobia mi prendesse una servente, ma non mi fido neanche a parlargliene. Mettiamo tutti pazienza, Agostino. Lo so che tu hai diritto a non averne più che tanta perché tu non sei della famiglia, ma abbi pazienza. Io posso dirti cos'ha Rabino che gli rode il cervello. La gran paura di non poter arrivare dove vuole arrivare prima che nostro figlio Jano lo chiamino a fare il soldato.
Sta di fatto che il secondo anno fu più galera del primo. Alla mia età cominciavo ad andar sbilenco come uno che ha vangato tutta la vita; si stortagnavano anche Jano e Baldino, ma io mi guardavo solo me, che poi non avevo il compenso della roba. Il mangiare era nella quantità di prima, solo a me sembrava sempre più scarso perché mi trovavo in crescenza di corpo e di fatica. Fu in quell'epoca che rubai il salame: non avevo mai avuto tanta fame e un'occasione così, con nessuno in cucina e sulla tavola un culettino di salame che forse la padrona pensava di sbriciolarcelo nella minestra, e il cane una volta tanto slegato che annusava la pietra della soglia. Saltato dentro, arraffai il salame e trafficavo per mettermelo in seno quando dalla finestra vidi venire per l'aia Tobia. Mi sentii tanto in colpa e così perso come se avessi ammazzato un cristiano, mandai giù intero il salame e scappai fuori. Mi salvò il cane che mi trovai tra le gambe e che mi diede l'ispirazione: a calci lo feci scappare e io dietro a gridargli del ladro e dell'assassino. Tobia credette al rubarizio del cane, quando lo riebbe alla catena lo lasciò quasi morto di botte e poi digiuno per due o tre giorni, ma a me quel salame, tra che l'avevo buttato giù e lo spavento, non mi fece nessun pro.
Si viene a una mira che uno è obbligato a farsi delle illusioni e va a cercare dell'aiuto dove non ce n'è neanche l'ombra; voglio dire che avendo ormai capito che per Tobia io ero solo una bestia da soma con lo svantaggio della parola, cercai l'occasione di farmi prendere in grazia, o anche solo mettermi in vista, dal padrone del Pavaglione che era superiore anche a Tobia. E ci tirai il colpo una volta che venne su per togliersi mezza giornata d'in farmacia e s'era ricordato del cane, gli aveva portato una cartata di carne che, dopo un giro sul fuoco, ci si saremmo gettati sopra io e anche i figli di Tobia.
Data un'occhiata alla terra, s'era ritirato sotto il portico con Tobia, a discutere. Io cominciai a girargli intorno e mi strinsi sempre di più quando sentii che non parlavano più d'interesse, ma del vento e della pioggia. Gli stavo ormai a due passi e aspettavo il momento buono d'entrare nel discorso con qualcosa che potesse far piacere al padrone, quando lui volta la testa e mi dice: - Tirati un po' più in là che hai un sudore allo zolfo che fa venir male.
Avessi avuto solo le mie miserie, ma mi si aggiunse un cruccio per Emilio, e senza che mio fratello c'entrasse lui direttamente; fu il prete giovane di Trezzo a farmi star male per Emilio. Una mattina che ero al pozzo a tirare un rosario di secchi d'acqua, lui capitò sull'aia e mi disse di chiamargli la mia padrona. Io lo conoscevo per averlo già visto allo sposalizio di Ginotta e perché era lui che tutte le feste ci faceva piantar lì di giocare al pallone per mandarci a vespro, e gliela chiamai fuori.
Le disse: - Non avete nessun lavoro da darmi, un lavoro qualunque ma che il giorno che ve lo porti fatto possa esser sicuro di mangiarmi pane e formaggio? - e nella voce e nel portamento somigliava tutto a quegli ambulanti che girano le nostre cascine, ma della qualità più disgraziata. Lei invece lo trattava proprio da prete, gli disse: - Ho paura di non aver proprio niente, don Pino.
Lui s'agitò dalla testa ai piedi: - Possibile che non abbiate niente di rotto in tutta la casa? Per esempio, il vostro svegliarino marcia? Perché se non marcia io son capace d'aggiustarvelo.
Lo svegliarino marciava, io potevo farle testimonio.
- Nemmanco una sedia da rimpagliare?
Io vedevo il tiramolla dentro la padrona; fosse stato solo per lei, lo favoriva subito, ma aveva paura di poi Tobia. Alla fine però gli disse che poteva dargli da rimpagliare il suo cadreghino, quello che adoperava nella stalla a filare. Lo portai fuori io, il prete lo guardò sopra e sotto e poi disse che era frusto, con le gambe tutte smangiate, e se lei ci stava lui gliene faceva uno nuovo. Ma la padrona non poteva andar tanto in là e per togliersi alla sua insistenza andò a prendergli una pagnotta e lei stessa gliela ficcò nella tasca della veste. Il prete ci posò sopra una mano e disse: - Voi non mi crederete, ma sono a una mira che sto pensando d'imparare a suonare il clarinetto per guadagnarmi qualcosa nelle feste.
Stemmo a vederlo andarsene col cadreghino sulla spalla, e quel giorno capii che i preti giovani somigliano un po' a noi servitori, hanno fortuna o sfortuna a seconda dei parroci che imbroccano, preciso a noi coi nostri padroni.
- La pena che mi fa quel povero don Pino, - disse la padrona: - il prete vecchio lo fa morir di fame perché lui s'è abituato a consumar poco o niente e non vuol capire che questo è giovane e con la pancia lunga. Ce n'è comodo per due nella parrocchia, ma il vecchio spende tutti i soldi a farsi cintare i beni. Fin da loro ci sono le differenze e le ingiustizie.
Da questo fatto mi venne il cruccio per Emilio: che dopo tanti sforzi e sacrifizi lontano da casa, una volta arrivato a cucirsi i bottoni neri, facesse la fine di questo don Pino. Di preti io ne conoscevo abbastanza bene uno solo, il nostro parroco di San Benedetto; è vero che mangiava di magro non soltanto al venerdì, ma se si fosse lamentato non l'avrebbe fatto in buona coscienza, ed era su di lui che io mi regolavo quando cercavo di figurarmi l'avvenire di Emilio nella chiesa. Ma dopo questo fatto del curato di Trezzo, io che ormai vedevo per forza tutto brutto, non potevo più liberarmi dal presentimento che mio fratello avrebbe avuto il medesimo destino di questo don Pino.
Passò un bel mese e poi finalmente Tobia mi portò giù ad Alba, una volta che ci andammo senza carro e lui aveva appresso solo la sporta della sua donna. Per prima cosa andai al seminario, traversando mezza Alba ma con poco occhio per la città.
In seminario, Emilio mi fece un'impressione ancora più brutta che la prima volta: aveva solo più degli occhi, e il collo non più grosso di quello d'un bambino di sei anni, per quello che me ne lasciava vedere una sciarpa di lana nera che non avevo mai saputo che ce l'avesse. E così gli domandai se gliel'aveva passata il seminario, ma lui mi disse che gliel'aveva portata nostra madre. Era venuta ad Alba un mese e mezzo prima, sul biroccio di Canonica, e finché aveva viaggiato sulle langhe era stata a cassetta, ma alla vista delle prime case d'Alba era passata dietro e s'era accovacciata dentro una corba, per paura e vergogna della città.
Io mi misi a dire: - Che stupida, nostra madre. Che stupida, nostra madre, - ma intanto giravo gli occhi per quella stanza dove lei era stata qualche sabato fa, ed ero talmente incantato che non davo nessuna risposta a mio fratello. Mi scrollai a sentirlo tossire; una tosse secca e maligna, che l'obbligava a tenersi il petto con le due mani, alla quale non feci abbastanza caso ma che invece avrebbe dovuto mettermi sull'avviso fin d'allora.
Mi disse: - Son solo contento che è finito l'inverno, perché non ne potevo più di rompere il ghiaccio nel catino tutte le mattine.
- Ma possibile che qui dentro faccia una siberia tale?
- Tu non ci crederai, ma fa più freddo qui dentro che sulla collina di Mombarcaro la notte di Natale.
- Hai delle novità?
- M'hanno messo nei cantori.
- Sarai contento. E' una distinzione, mi sembra. E a essere nei cantori c'è dei vantaggi?
- Ma io sono stanco, Agostino, e tutte le mattine che mi levo devo cercare i miei pezzi nel letto. Quando sei stanco a questa mira, anche cantare diventa pesante. Dopo lo studio gli altri che non sono nei cantori si riposano, ma noi andiamo in cappella a provare -. Mi disse anche, forse con l'intenzione di svariarmi: - Però cantiamo delle cose e in una maniera che se ci sentiste voi di San Benedetto restereste a bocca larga.
Ma io non mi lasciai portar lontano, anzi quel suo parlare di fatica e di sacrifizio mi fece venire in mente la storia di don Pino e in quattro parole gliela tirai giù.
Lui alla fine sorrise e mi disse: - A me non dà nessun fastidio quello che può aspettarmi dopo.
- Io invece al tuo posto il fastidio ce l'avrei fin d'adesso. Perché si tratta del mestiere che farai per tutta la tua vita e come t'ho contato c'è anche del brutto.
- Ma tu sei sicuro che io ci arrivi a esser prete?
Io la presi nel senso che Emilio non se la togliesse in quella specie di scuola, lo sapevo anch'io che in seminario si può restar bocciati tal quale nelle nostre scuole basse. Allora gli domandai come andava negli studi, con quel latino; a parlargli di queste cose, io che avevo sempre solo avuto la zappa in mano, ero un po' genato, ma in fin dei conti ero suo fratello più vecchio.
Emilio difatti rise: - Io non dicevo mica del latino. Non è mica quello che mi fa paura. Ce n'è almeno mezzi più indietro di me.
Ce ne capivo così poco che non mi sentii neanche di farmi spiegare. Lui era andato a sedersi su una panca, sotto il ritratto del vescovo, e di là mi domandò se ero venuto giù per mio conto.
- No, ho il padrone che m'aspetta dall'altra parte d'Alba.
- Sei ben bravo, Agostino, a farti tutta quella strada per venirmi a trovare.
- Io per venire a trovar te lascerei un pranzo di sposa. Solo potessi vederti una volta in un altro posto che qui. Non si può passarci una mezza giornata io e te insieme, fuori per Alba, un po' più avanti nel caldo, nei giardini pubblici o magari in riva a Tanaro?
- Dànno il permesso solo a quelli che hanno la fortuna d'avere dei parenti in Alba. Ma chissà che noi due non possiamo vederci a casa, e fare insieme un giro lungo Belbo, ma dal mattino alla sera, e con da mangiare appresso. Cerca di farti dare dal tuo padrone una licenza nell'epoca che io mi trovo a casa in vacanza.
Gli dissi: - Si vede che non sei più di campagna. All'epoca che tu sei a casa in vacanza io lassù ho il grano e poi le uve.
Come l'altra volta si sentivano ogni cinque minuti, da dentro, delle scampanellate e tutte ci facevano fermare il discorso; finché suonò quella buona e lui dovette correre via. Prima ci baciammo sulle guance e io gli lasciai una lira perché si comprasse un po' per volta qualcosa che lo rallegrasse.
Ritrovai Tobia dov'eravamo rimasti intesi, ma invece di pigliar subito la strada delle langhe, mi portò con sé a trovare il nostro padrone, non a casa, ma nella farmacia. E' quella in via Maestra, per andare al duomo, con delle bisce d'oro pitturate su tutti i vetri, dentro rivestita d'un legno antico e lustro come il coro della nostra chiesa di San Benedetto, e le scansie piene di vasi che tante coppie di sposi delle nostre parti sarebbero ben contente d'avercene uno nella stanza da letto.
Il nostro padrone era fuori del banco, parlava da in piedi a un suo amico seduto al chiaro presso la vetrina, discorrevano di fucili da caccia di chissà che valore. Tobia gli chiese scusa e disse che eravamo passati solo per dargli il saluto e vedere se gli bisognava qualcosa dal Pavaglione. Mentre il padrone domandava a Tobia se su da noi aveva piovuto come in Alba, entrò una donna con una ricetta. Il padrone passò dietro il banco e le preparò il pacchetto, e bisognava vedere che cerimonie gli faceva quella donna che pure gli portava del profitto. - Che mestiere, - mi fece piano Tobia, - che mestiere che ha per le mani -. Il padrone prese i soldi della donna e li ficcò in una macchinetta che da lontano sembrava d'argento e che quando ebbe i soldi nella pancia fece drin! A me e a Tobia si drizzarono le orecchie.
Poi Tobia andò a parlare al padrone un po' da parte, ma si sentiva lo stesso. Gli diceva Tobia: - Ho lei che da un po' di tempo si lamenta e credo che non lo fa per finta ma che si sente proprio niente bene.
- Cosa si sente?
- Sarà forse una gran infiammazione, io non lo so, ma si lamenta a tutte le ore e s'è fin messa la verbena sulla pancia.
Tobia non gli avesse mai parlato della verbena; il padrone s'arrabbiò e alzò la voce: - Ah, s'è messa la verbena sulla pancia! Almeno se n'è messa una forcata? Gioco cento lire contro un soldo che è andata dal settimino del Villaio.
- No no, dev'essersela messa lei di sua scienza.
- Bella scienza! - Il padrone s'era voltato da quel suo amico e gli disse: - Vedi al caso pratico le teste che abbiamo sulle langhe? - e quel signore abbassò la testa come per dire che conosceva anche lui la nostra razza. Poi il padrone si riattaccò a Tobia: - Ma tu non sai dirmi proprio niente di quel che si sente, che io possa conoscerle il male da qui? Punto primo, le sue mestruazioni le vengono sempre?
- Veramente io delle sue ministrazioni non sono mai stato al corrente.
- Cammina china?
- Mi sembra.
- Si tiene i fianchi?
- Mi sembra anche.
- Tobia, la tua donna è frusta. E' ora che le prendi una servente.
- Quel che costa una servente.
- Con tre marenghi e un grembiule a Natale, fai quello.
- Io non posso.
- Io so che puoi.
- Che voi sappiate, ma che io non possa -. Tobia rispondeva secco, tutt'altro che da mezzadro a padrone; non c'era niente come toccarlo nei soldi che lo facesse diventare uomo.
Allora il padrone gli disse: - I tuoi conti voglio vederti a farteli quando l'avrai sotterrata.
- Ma lei è frusta a quella mira lì?
- Basta. La prima volta che vengo su la guardo io.
- Noi v'aspettiamo. E quando venite su?
Al posto del padrone parlò quel suo amico, disse ridendo: - Furbo quel padrone che avvisa il mezzadro di quando va a trovarlo.
Rise anche il padrone e perfino Tobia, mentre uscivamo, gli disse: - Allegro, padrone -. Ma appena fuori nella strada, mi fece: - L'hai vista quella macchina che fa drin tutte le volte che uno ci mette dei soldi? Averne una io, e avere i soldi del padrone da metterci dentro. Sentire un drin ogni cinque minuti. Uno scudo e drin! Uno scudo e drin!
Si può dire che anche dopo passata la stagione del gioco non avevo mai smesso di veder Mario Bernasca, ma sempre in compagnia, e poi cabalizzavo per delle giornate sulle parole che in quelle occasioni mi buttava: non dicevano niente di preciso, ma promettevano di vederci una buona volta testa a testa e di spiegarci ben bene. Difatti, una domenica dopopranzo, salì al Pavaglione e mi chiamò ad andar con lui a bagnarci in un gorgo di Belbo; io da dentro la casa gli domandai se con noi venivano degli altri, e sentendo che no, indovinai che quella era la volta buona.
Eravamo in mutande seduti sulla riva, dopo che c'eravamo aiutati ad asciugarci la schiena. Mario parlò:
- T'ho sempre detto che me e te siamo due bei stupidi. E difatti perdiamo la nostra gioventù a fare i servitori, e sotto che pidocchi di padroni, quando mi sembra che abbiamo la forza e i numeri per fare da noi. E perché dunque non ci mettiamo per nostro conto? Per esempio, non ci mettiamo a fare i mietitori? Non hai mai pensato alla vita che è? I padroni vanno a ingaggiarli ad Alba, li portano su e poi li riportano giù col calesse e se non ce l'hanno l'affittano perché i patti li fanno i mietitori, e da mangiare bisogna fargliene come vogliono loro, perché se vogliono la salsa del diavolo i padroni devono fargli la salsa del diavolo, e nel mentre si pigliano delle libertà con le donne della casa perché tanto all'indomani sono da tutt'un'altra parte. In una giornata si mettono in tasca cinquanta soldi e fino a tre lire e all'indomani ricominciano da un'altra cascina.
- Però il grano si taglia solo una volta all'anno, dissi io.
- Ma dà da fare per un bel po' anche dopo. Io so che i mietitori hanno il lavoro assicurato fino all'autunno, e sempre per via del grano; per due mesi buoni hanno da fare a trasportare i grani alla stazione d'Alba. Tu forse non gli hai mai parlato assieme a questi mietitori che vengono su da Alba, ma l'altra estate io ho parlato con uno di loro che era ingaggiato al Rustichello, e gli ho fatto tante di quelle domande che alla fine m'ha mandato a dar via l'organo ma intanto son venuto a sapere un bricco di cose. Be', quello là aveva il lavoro assicurato fino a ottobre, e sempre solo col grano.
- Ma e poi dopo?
- Poi dopo finisce, sarebbe bella. Ma tu hai un fondo di soldi in tasca e giù in Alba c'è tanto di quell'altro lavoro per gente come noi. Tutto lavoro che le nostre mani sono capaci, perché a servire in campagna ti viene la pratica d'un po' di tutto. Ad Alba potremmo aggiustarci come panettieri o come macellai, da garzoni s'intende, o anche come stallieri.
Io lo lasciavo dire, e guardavo l'acqua perché Mario non mi leggesse negli occhi che non avevo il coraggio di risicare e che neanche lui me l'avrebbe mai messo. Ma era fino, e mi disse subito: - Non ti senti il coraggio? Sei anche tu di quelli che crepano sulle langhe solo perché ci sono nati? O hai paura che a vivere in giro da solo ti vadano tutti i soldi che guadagni e a casa non puoi mandar più niente?
Cominciai a dirgli che questa poteva anche essere una ragione.
- Bravo ebete, - m'offese lui, - pensa ai tuoi di casa, che loro a te ci hanno già pensato. Il meglio che han saputo fare è stato d'aggiustarti da servitore da Tobia.
Mi risentii un po' e gli dissi: - Io non so te coi tuoi, ma io coi miei non ce l'ho amara. E poi qui c'entra il mio naturale. Io sono un disgraziato, che è difficile trovare il compagno girassi tutte le langhe, ma io di fare il vagabondo non me la sento. Da Tobia dormo su un paglione, ma il giorno che non sapessi dove dormirò la sera io sono un uomo perso.
Lui s'arrabbiò: - E vuoi, o stupido, che ad Alba non ci sia un paglione? Se va bene, ad Alba ci saranno dei letti per noi -. Guardò in giro per potersi poi rivoltare da me con un'aria meno accanita, ma era più acceso di prima quando mi disse: - Io sono disgraziato né più né meno che te, ma almeno io non mi do più le arie di figlio di famiglia.
Per forza che a Bernasca montava la rabbia; io me ne stavo lì con una faccia mezzo e mezzo e a parlare più da bambino che da uomo, mentre lui aveva il fuoco sotto e il bisogno di sentire da me una parola ferma. Ma non potevo mica dirgli a un originale come Mario che, a parte il coraggio e il naturale, conservare il posto da Tobia era per me una maniera come un'altra di tener la memoria di mio padre che mi ci aveva aggiustato prima di morire, e di salvare il rispetto della mia famiglia, che almeno avrebbe sempre saputo dove ero il giorno e la notte.
Ma lui giocava tutte le sue carte e mi disse di considerare anche dell'altro: - Se dopo i grani ad Alba ci va storta, non siamo per niente persi, perché possiamo sempre riaggiustarci da servitori.
- Voglio vedere il calcio in culo che mi darebbe Tobia.
- Ecco lì lo sbaglio, - gridò lui, - ecco la tua piccolezza! Per te esiste solo Tobia, il sole si leva soltanto sul Pavaglione. Sei mica matto che torneremmo ad aggiustarci su questa langa, dove la terra dà la scusa ai padroni di trattarci male. Andiamo ad aggiustarci da tutt'un'altra parte: in val di Diano, se possiamo. C'è un ragazzo del mio paese che ha la fortuna d'essersi aggiustato in val di Diano, e io gli ho parlato insieme una volta. Bisognava sentire, e ci gioco la testa che erano tutte verità, non che dicesse solo per farmi invidia. A parte la terra che là è più tenera, la mentalità di quei padroni là, che al paragone i nostri fanno schifo e si meriterebbero una zappata sulla testa. Là alla domenica i padroni ai servitori gli regalano a testa una coppia d'uova da cambiare alla censa col tabacco da fumare tutta la festa, ti dànno licenza di ricevere i tuoi amici nella loro cantina, e non parliamo del vino, ma c'è sempre a disposizione un cestone di pane e un bariletto di peperoni sott'olio. E' inutile, se hai per destino che Santo Stefano sia la tua festa, devi aggiustarti al largo. E là sono cascine grosse, madame di cascine, che hanno tutte cinque o sei servitori come niente. Vedi lì che non c'è da tremare se ad Alba non ìncontriamo. Ma io sono sicuro che, con tre mesi davanti, ad Alba ci aggiustiamo bene.
Quando capì che s'era sbagliato a far conto su di me, e che io gli tiravo fuori cento parole per dispensarmi, allora s'alzò da vicino a me dove s'era messo per meglio convincermi e da lontano quattro o cinque passi mi gridò che ci andava da solo.
- Quando ci vai?
- Andrò. La farò vedere a tutti su questa langa, la farò vedere a te per primo.
Tornammo su, che tra me e Mario Bernasca tutto era finito non appena era cominciato sul serio, e lui non passò nemmeno più al Pavaglione; per lasciarmi e schivarlo tagliò per i rittani. Io arrivai a casa con una faccia che Tobia dovette annusare qualcosa, tanto che quella sera mi fece, ma come per caso: - E' buono come il sole, Mario Bernasca, ma nella testa è più fallito che il fante di picche -. Non gli diedi risposta, quella sera Tobia potevo soffrirlo meno che mai; m'empivano la testa quei padroni della val di Diano.
Laggiù in riva a Belbo pensavo che Bernasca m'aveva interessato perché ci teneva a me, a farmi migliorare assieme a lui, ma nella notte stessa mi persuasi invece che l'aveva fatto perché da solo non aveva tutto il coraggio che ci andava per scappar dalle langhe e cercar fortuna giù in Alba. A ogni modo, da quella domenica, se potevo schivarlo lo schivavo, perché anche in compagnia mi genava trovarmi con lui, peggio che gli dovessi dei soldi.
Se da quelle parti là si ricordano ancora di me è solo perché sono stato io che trovai Costantino del Boscaccio.
Quelli del Boscaccio erano una razza che teneva sempre la testa tanto in su da non saper mai se in terra era asciutto o bagnato, tutti avevano più caro non vederseli sull'aia, neanche per aiutare a spogliar la meliga, e quando avevano ragione la gente era tutta d'accordo a dargli torto e se avevano torto ce l'avevano di natura. Sebbene fosse la cascina più prossima al Pavaglione, noi non ci facevamo mai niente insieme, perché con Tobia non si parlavano a causa d'un gesto che Tobia aveva fatto a Costantino in un'epoca quando io nemmeno mi sognavo di finir servitore al Pavaglione: si trovavano in festa a Montemarino tutti i cascinai di lì intorno e Costantino aveva portato la sua fisarmonica ma, attaccata la prima aria, Tobia già ubriaco aveva solo fatto che prendere un paio di forbici lì sottomano e gli aveva dato una coltellata nel soffietto. I compagni gliela fecero aggiustare con due scudi, ma da allora non si parlavano più.
Un giorno si slarga la voce che Costantino mancava da casa. Mi ricordo che la padrona disse subito: - E' un gran villano. Già un'altra volta ha detto alla sua donna che andava ad ammazzarsi, ma solo per farla spaventare e piangere -. Ma Tobia disse: - Però stavolta, proprio perché non l'ha detto, stavolta è proprio partito per ammazzarsi. E' una catena. L'ha già fatto suo fratello, che l'hanno trovato penduto alla travata venti e passa anni fa. Costantino ha già resistito fin troppo -. Allora Jano disse: - Non può essere che sia sceso ad Alba e là si sia gettato in Tanaro? Non sarebbe il primo, - e dopo Jano anche Baldino voleva dire la sua, ma la padrona lo fece star zitto perché non erano cose da ragazzi e poi a lei che non stava già bene facevano troppo effetto.
Su tutta quella langa, giorno e notte, non si sentiva più che chiamare Costantino, a un bel momento chiunque non sapeva cosa fare dava una voce a Costantino. La famiglia diede la larga al cane che aveva un'affezione speciale per il padrone vecchio e i figli gli tennero dietro per esserci al caso che trovasse, ma il cane che stava legato tutto l'anno se li portò dietro fin passato Le Grazie solo per trovare una sua cagna. Intanto la gente, ciascuno per suo conto e senza passarsi la parola, aveva già scandagliato bene i suoi pozzi, lascio immaginare con che disgusto per me che avevo ancora abbastanza fresca la disgrazia di mio padre.
Noi c'eravamo già fatta l'idea precisa che Costantino fosse andato ad ammazzarsi e avevamo i nostri sentimenti già bell'e pronti, e quindi ci patimmo un po' quando si seppe che Costantino l'avevano visto all'osteria di Campetto che mangiava pane e salciccia e se ne sbatteva di tutto e di tutti. Corse a Campetto suo figlio più giovane, ma non era vero niente. Quella sera tennero aperta la chiesa di Cappelletto apposta per chi voleva pregare per Costantino che fosse ritrovato vivo, e la padrona ci andò, ma Tobia scuoteva la testa; per lui era tutto cammino e fiato sprecato; a quest'ora Costantino faceva già i vermi, e bisogna dire che Tobia era uno che sapeva.
A Tobia tutto questo traffico per Costantino andava per traverso perché noi sulla terra lavoravamo disturbati e di malavoglia e alzavamo sovente la schiena a guardar su all'aia del Boscaccio, invidiavamo la gente che poteva preterire il lavoro e stava lassù delle ore ad aspettar le novità; noialtri soltanto alla sera potevamo metterci al corrente.
Una mattina arrivò al Boscaccio un uomo di Rocchetta e raccontò ai figli che lui doveva aver visto loro padre, però era già una settimana fa: - L'ho visto sul mercato del mio paese, - disse: - io ero lì a sentir uno che contava d'un suo conoscente che s'era impiccato nella settimana. Appena finito, entra nel nostro cerchio un uomo che era vostro padre di sicuro, mette una mano sulla spalla a quello che aveva contato e gli fa: "Ha avuto del coraggio, quel vostro amico, ha avuto del coraggio", e poi se n'è andato non so verso dove.
Tutti restarono lì e solo dopo un po' il figlio più vecchio domandò cosa quel fatto voleva dire. - Mi sembra che voglia dire più della metà, - rispose quello di Rocchetta. Basta, dovettero mettersi tutti in mezzo perché il figlio più vecchio non lo strangolasse, in paga d'essersi fatto tre colline per metterli sulla strada di loro padre e invece di passargli da bere.
Costantino mancava ormai da diciassette giorni, quando noi al Pavaglione restammo senza più un pugno di crusca e Tobia non trovò a farsene imprestare meno distante che alla Galla, che è a metà strada tra il Pavaglione e Trezzo. Io andai alla Galla, mi caricai il mio sacco e poi me ne venivo su a once, quando mi piglia voglia di fare un bisogno. Ma lì vicino c'erano due ragazze in pastura e per quanto mi lontanassi dalla strada rimanevo sempre in vista. Passo più passo meno decisi allora d'entrare in un boschetto d'arbusti di rovere, così serrato che sembrava d'entrare in uno stanzino, e schivati i primi rami mi vidi contro lo stomaco i piedi di Costantino. Era lui, anche se non ce la feci a guardarlo in faccia, il più su che arrivai con gli occhi fu il petto, dove aveva appuntato un foglietto tutto scritto.
E' già stato tanto aver avuto la forza di scappare e non crollare come morto sotto i piedi di Costantino. Risalii sulla strada senza toccar terra, gridando e avventando in una maniera che quelle due ragazze non si sentirono d'aspettarmi e scapparono, scapparono anche le pecore, e perfino gli uccelli scappavano nel cielo. Agli uomini lontani e sbardati urlai due o tre volte che avevo trovato Costantino impiccato, e gli feci il segno delle mani intorno al collo, poi cascai seduto sulla strada e mi misi a vomitare che non la finivo più, come se avessi il didietro in bocca.
La gente arrivava sfrenata, mi chiedeva solo dove e io mostravo col dito quel boschetto d'inferno. Quando ne uscivano si tenevano tutti il naso tappato come contro una puzza tremenda, io non l'avevo sentita per niente, mi spiegarono poi che dovevo aver avuto il vento contrario. Uno per uno venivano a posarmi una mano sulla spalla e mi dicevano: - Che brutto piatto, giovane, ti sei visto davanti -. Venne anche Tobia, e a lui domandai cos'era quel pezzo di carta che aveva sul petto, che a me sembrava la vendetta scritta di qualcuno; era invece il ricordino del cinquantesimo di messa del parroco di Trezzo, e secondo Tobia Costantino doveva aver pensato di metterselo sul cuore per farsi perdonare in parte da nostro Signore. Gli domandai anche se era morto da poco, ma mi disse che aveva già più vermi addosso lui che una robiola marcia.
I figli di Costantino sapevano già tutto e arrivarono col carro, volevano caricarci loro padre e portarlo diritto al camposanto di Trezzo, dato che s'era ammazzato più vicino al camposanto che a casa. Si misero in mezzo Tobia e gli altri vecchi dandogli dei matti e non glielo lasciarono toccare neanche con un dito perché prima doveva vederlo com'era il maresciallo di Neive.
Tobia era contrariato perché io perdevo del tempo ad aspettare il maresciallo che m'interrogasse, e aveva anche paura che gli perdessi un'altra mezza giornata se la cosa era poco chiara e veniva su il capitano da Alba; però il sacco a casa lo fece portare da Jano e Baldino e lui restò con me a farmi coraggio mentre rispondevo al maresciallo.
Io che l'ho trovato sono stato quello che l'ha visto meno bene di tutti: non mi son mai lasciato scappare che in faccia non l'avevo guardato, ma quando contavo la mia avventura, e me l'avranno fatta contare cento volte, nei particolari della lingua e degli occhi m'aiutavo con quello che avevo sentito dagli altri.
Poi Tobia si pigliò la prima botta sulle orecchie. Una sera che mancava poco a cena, invece di chiamarci a mangiare, sentimmo la padrona lamentarsi forte tutto d'un colpo e poi gridare che perdeva sangue; quando fummo tutti in cucina, ci disse che non aveva la forza di tenere e neanche d'andar da sola a coricarsi. I suoi tre uomini la portarono su, mentre io mi fermai al fondo della scala, ma poi Baldino mi gridò che sopra c'era bisogno di chiaro e allora salii col lume.
C'era un odore di donna che passava sopra all'odore delle patate stese sull'ammattonato, e Tobia richiudeva in quel momento un tiretto anche se c'era una manata di lingeria presa in mezzo.
- Hai visto, Rabino? - diceva la padrona con una voce che a me sembrò d'agonia: - Sono andata andata andata, ma adesso sono bell'e ferma. Hai voluto non prendermi la servente, ma adesso vedi.
Le disse Tobia: - Non me n'hai mai parlato di prenderti una servente.
- E' che se te ne parlavo tu mi caricavi di nomi e magari di botte. Ma che uomo sei se non t'accorgi che avevo bisogno d'una servente per tirare avanti? M'hai sempre adoperata come se fossi una macchina di ferro, ma adesso vedi che son solo di carne e d'ossa.
Lui si piegò sul letto e ridendo le disse: - Ma hai paura di morire? - Son pronto a giurare che aveva riso e parlato così con buona intenzione e solo per rinfrancarla, ma lei lo capì per uno scherno e da distesa pigliò a schiaffeggiare a due mani la faccia china di Tobia che, fissato lì dallo stupore, non ne schivò neanche uno; poi si drizzò e si scostò di qualche passo dal letto.
La padrona si toccò un po' sotto la coperta, poi tirò fuori le mani e se le mise sugli occhi, e così da cieca diceva, che doveva aver perso la nozione di chi c'era nella stanza: - Adesso sì che mi prenderai la servente, adesso che m'hai rovinata. Hai cominciato a rovinarmi fin dal principio. Ti ricordi quando dovevo comprare la prima volta? Era il mio primo e lo sapevi bene che il primo non è mai cavaliere. Nossignore, m'hai fatta sgobbare quando mi mancava solo più un giorno. Ricordati sempre, Tobia, che m'hai fatta lavorare dietro al fieno che io perdevo già l'acqua!
Allora Jano si strinse la testa fra le mani come se volesse staccarsela e buttarla via, fece così un giro su se stesso e poi si fermò puntato a Tobia e gli gridò: - Vigliacco d'un padre, ma lo sai che io t'ammazzo con un pugno?
Mentre la padrona cominciava a gridare, Tobia disse a Jano: - Che bel gesto che faresti, uno giovane come te a picchiare un vecchio come me, - ma parlando s'era chinato alle patate e quando si ridrizzò aveva un falcetto in mano. Gridò: - Adesso voglio vedere i tuoi gran pugni, o bastardo! - e si gettò su Jano. Senza che fossi urtato io lasciai cadere il lume e tra me e Baldino imbalsamati dalla paura passò Jano che scappava e Tobia dietro col falcetto alzato. La padrona aveva la forza d'urlare ma non d'alzar la testa, Baldino balbettava, io quando li sentii finir la scala e correre in cucina, mi sbattei alla finestra e vidi Jano scappare rasente alla casa, mentre Tobia si fermava sull'uscio, abbassando il falcetto. Andai a dirle che Jano s'era salvato e che aveva preso per il bosco, lei si segnò e poi mi disse: - Di' a Tobia che t'apra il credenzino. C'è del lardo, te ne tagli un bel pezzo, che tu abbia almeno da cena.
Ma io non osavo accostare Tobia solo per parlargli di mangiare, e poi lo spavento m'aveva addormentato lo stomaco, non m'era mai capitato di trovarmi così vicino a veder correre il sangue, e poi quando scesi Tobia non lo trovai più. Mi passò accanto Baldino, ma non si fermò con me, andò dai peri a stare e pensare per suo conto. Potevo ritirarmi nella stalla, ma era una bella sera da godere almeno un momento, e così girai la casa per farmi due passi allo scuro sulla strada di Mango. Ma girata la casa, vidi subito Tobia: era seduto sul tronco a ridosso del muro, proprio sotto la finestra della stanza sua e della padrona; si teneva la testa fra le mani e si parlava da solo, ma non potevo sentir niente di quel che si diceva per via dell'aria che portava subito via le parole. Dopo un minuto alzò la testa e parlò forte, ma forte come uno che volesse farsi sentire fin sulla langa di Castino là in faccia. Disse: - Già, io non son mai andato con la pancia per terra, io mai. Lo sanno tutti che faccio una vita più bella dei preti. Io mi sono frustato tanto come te, solo che io non ne parlo mai e se mi viene del male lo nascondo, per forte che sia. Cosa ti credi, t'è passato di mente che ho sessantadue anni, e che lavoro tanto che altro che perdere il sangue, se avessi anch'io il buco da perderlo! E giusto che parlavi del fieno, lo sai cosa vuol dire alla mia età tagliare il fieno da quando il sole si leva a quando si corica? Da giovani come i tuoi figli e con la rugiada son tutti buoni a tagliare, ma quando il sole viene alto e il fieno mette il pelo volatino, allora sì che il fieno ti domanda quanti anni hai! Ecco, se è per la questione del fieno!
Stette come ad aspettare che la padrona gli rispondesse dalla loro stanza, ma niente venne da lei, salì invece dal rittano la voce di Jano che faceva a suo padre: - Assassino, assassino, sei un assassino! - Tobia andò fin sull'orlo del rittano e gridò giù: - A te ti dico questo: prova solo a non trovarti sul lavoro domani mattina. Ti dico solo questo -. Aspettammo tutti che Jano rispondesse, ma non si fece più sentire da là basso; invece sull'aia s'era messo a gridare Baldino, per far star zitto il cane che la voce lontana e sfisonomiata di Jano aveva aizzato.
Tobia tornò a sedersi sul tronco, lo sentivo sbatter la lingua per rifar saliva dopo quella gridata, e poi disse, ma più piano: - Qui mi tenete tutti per il vostro aguzzino. Ma lo sapete il perché io tiro e vi faccio tirare e non vi do niente di più del necessario. E se anche fallisco nei miei piani, dovrete sempre ringraziarmi per avervi insegnato a star male oggi per non star peggio domani. E non venite a dirmi che peggio di così non si può stare, perché io ci metto poco a mostrarvi il contrario. Vi contassi d'uno che da bambino gli è morto suo padre e se lo prese in casa un suo zio, dalle parti di Cravanzana. Lo faceva tirare che al paragone voi siete dei signorotti, e a mezzogiorno gli diceva: "Se non mangi pranzo, ti do due soldi", e bisognava pigliare i due soldi, e a cena: "Se vuoi mangiar cena, mi devi dare due soldi". Ero mica io quel bambino là? Voi non avete mai provato niente.
Da sopra arrivò la voce della padrona, diceva a Tobia d'andare a coricarsi, che era in piedi dal romper del giorno, ma che prima mangiasse qualcosa, si bevesse un uovo: - Quant'è che non senti il gusto d'un uovo, o povero disgraziato?
Io n'avevo il cuore pieno e mi ritirai nella stalla, riflettendo sulle cose che ci sono nelle famiglie e domandandomi se nostra madre, ripensando al suo uomo morto, doveva far posto nel suo ricordo a dei fatti così.
La fame non mi lasciava addormentare, ed ero ancora sveglio quando, sarà già stato mezzanotte, sentii aprirsi l'uscio della stalla; allungai una mano al forcone, ma mi venne incontro la voce di Jano: - Sei sveglio, Agostino? Fatti un po' più in là, che stanotte ci dormo anch'io sul tuo paglione.
La servente arrivò prima dello sperato: veniva dalla langa di Castino ed era ancora parente di Tobia, quantunque parentela passata sul raspo; si chiamava Fede e andava per i diciotto anni.
Siccome per questa ragazza io avevo allora un pallino in un'ala, si potrebbe credere che ancora adesso io la faccia meglio di quel che fosse, eppure è la verità che era una ragazza piena di finezza, che sapeva fare e figurare meglio di tutte le ragazze che c'eravamo abituati noi. Lei poteva stare per delle ore al fornello e poi voltarsi pulita come se in tutto quel tempo non avesse fatto che la signora, si muoveva sui suoi zoccoli senza mai sbatacchiarli, e la sua voce aveva più d'un tono, come la voce delle donne d'Alba. Ma con tutta la sua grazia bisognava vederla sul lavoro e il sollievo che dava alla padrona, la quale aveva fatto presto la pace con Tobia che gliel'aveva trovata e presa. E quando uno credeva che avesse finito di far tutto, lei si metteva alla finestra all'ultimo chiaro e ci dava dentro a far solette, non si possono contare le solette che ci ha fatto. Mi ricorderò sempre che le rare volte che sbagliava una cosa aveva il vizio di succhiar giù l'aria come se si fosse punta con un ago, e allora si sentiva Tobia: - Stai più attenta, o bagascetta -. Mangiava sempre da in piedi, gliel'avevano insegnato i suoi in vista d'aggiustarla da servente, perché i padroni son più contenti se i servitori si sbrigano a mangiare.
Giovane com'era, aveva già visto le sue, che metà bastavano. Aveva tre fratelli, ma due le erano già morti, tutt'e due di tifo e uno dietro l'altro; i suoi di Fede capirono tardi che il letamaio era troppo vicino al pozzo. E poi aveva una sorella più vecchia, ma con la tisia, e io ho creduto di capire che proprio per lei Fede è andata volentieri da servente. Sua sorella se ne partiva, ma troppo adagio per la pazienza di sua madre, e Fede non resisteva più a vedere come la trattava e lei non poter mai parlare; sua madre ormai non faceva più che sbuffare e dire a chiunque capitava, fosse magari un vagabondo sull'uscio: - Sono talmente stufa di doverle sempre far da mangiare da parte e poi lavar subito la sua roba, doverle far sempre tutto da parte, che ho più caro che muoia. Ma sembra che crepi a morire.
Adesso io e i figli di Tobia sapevamo cosa fare il dopopranzo, non ci lontanavamo più dall'aia e aspettavamo che lei uscisse a rovesciar l'acqua o a metter le scodelle ad asciugare al sole, se facendo qualche gesto non lasciasse veder qualcosa di bello, che non ci sarebbe scappato di sicuro perché nessuno dei tre batteva più palpebra. Il giorno che era arrivata, Tobia voleva metterla a dormire in cucina nell'angolo del fuoco, ma la padrona la fece dormire sempre nella sua stanza, ammucchiò le patate e le allungò un pagliericcio. Neanche di giorno la perdeva d'occhio, perché sapeva con chi aveva da fare: se penso a quella volta che colse suo figlio più giovane nella stalla con la troia e le cinghiate che gli diede sul didietro nudo, e in quel bruciore Baldino gridava soltanto: - Ma quest'inverno che l'ammazziamo le troviamo dentro il bambino?
Me mi trattava bene Fede, e da parte mia io ero sempre solo all'agguato per vedere se potevo darle una mano in qualunque cosa, e questo fin dal primo giorno. Una sera spogliavamo la meliga e sull'aia del Pavaglione ci sarà stata mezza la gioventù di lì intorno: Tobia comanda a Fede di fare il giro di chi ha sete, lei fa il giro e a tutti passa acqua e aceto e a me dà del vino. Mi misi subito a cabalizzare che segno poteva esser questo e senza dar nell'occhio girai tutta la compagnia e a ciascuno domandai cosa gli aveva dato Fede da bere: il vino l'aveva dato a me solo, e allora mi feci subito tante idee e venire una gran speranza. Purtroppo quella sera finì malamente per me, e non per colpa di lei, ma tutta di Jano che quando finimmo di spogliare e ci mettemmo a cantare e a far gli scherzi, si ficcò un cannone di meliga in mezzo alle gambe e saltando come un montone perseguitò Fede per cinque minuti finché lei dovette chiamare aiuto alla padrona. Non ci voleva nient'altro perché io cominciassi a sognare il giorno che Jano doveva partir soldato, e auguravo male a tutto quello che Tobia studiava e faceva per averlo riformato; fui ben contento quella sera che Tobia tornò su da Alba e disse che il farmacista nostro padrone non poteva far niente per Jano all'ospedale militare di Savigliano. E m'aveva anche fatto piacere che se ne fosse andato Mario Bernasca, perché Mario aveva dei numeri e non era fuori del caso che facesse colpo su Fede. E già che ci sono, conto come scappò da servitore, perché Bernasca ha avuto la sua importanza nella mia vita di quei tempi.
Mario Bernasca fece quello che m'aveva detto giù in riva a Belbo: sparì una notte senza metter nessuno al corrente. Dimodoché alla mattina i suoi padroni si fecero subito l'idea che per scappare così doveva avere qualcosa attaccato alle mani e nell'affanno suonarono il corno, che veramente si suona soltanto per i furti di bestiame. Tutti i cascinai volarono a valle per tagliar la strada ai ladri, ma ebbero un bel cercare la pesta delle bestie e battere tutti i cespugli. Si misero i fucili a spalla e dissero al vecchio del pilone del Chiarle di farsi coraggio e una croce sulle sue bestie. Solo allora il vecchio spiegò che di bestie dalla stalla non gliene mancava neanche una, ma che si trattava di Mario Bernasca che nella notte gli era scappato da servitore portandogli via della roba. Tutti, specie i più giovani, si misero a dirne di Mario come se Mario non avesse fatto che rubare da quando era nato, finché uno gli domandò cosa gli aveva poi rubato. Il vecchio s imbrogliò e disse che non poteva ancora saperlo di preciso perché non s'era fidato a perder tempo a fare il conto della roba. Allora se la pigliarono con lui e gliene dissero d'ogni colore, anche se poteva essere il nonno di tutti. Finì lì, e da quelle parti Mario Bernasca non l'ha più rivisto nessuno. Però si venne a sapere che quando scappò era liscio come un'asse: il giorno prima il suo padrone l'aveva mandato al forno a Manera e mentre il pane cuoceva il figlio del panettiere l'aveva piumato giocandogli insieme al nove sulla pietra del forno.
Siccome avevo visto che, una volta che eravamo andati tutti in festa a Trezzo, Jano aveva comprato a Fede una barra di torrone del Gallo e lei l'aveva accettato di buona grazia, schivai un po' di soldi e la prima volta che scesi ad Alba le comprai a un banco in piazza un bottiglino d'acqua d'odore, che mi venne venticinque soldi. E con quel bottiglino in fondo alla tasca andai a trovare mio fratello in seminario, ma stavolta non gli lasciai niente per comperarsi da mangiare perché i soldi m'erano andati tutti nel regalo a Fede. A casa, lo seppellii nel paglione e aspettavo l'opportunità di darglielo: avrei potuto metterglielo in mano in un attimo e di nascosto dagli altri, ma volevo aver l'occasione di parlarle un po'. Ma non riuscivo mai a incantonarla, perché quando non avevo addosso gli occhi dei padroni avevo quelli dei due figli.
Fede mi trattava sempre bene e mi guardava più dolce che agli altri, ma questo non mi bastava più, e poi io sono forgiato in una maniera che passo l'indomani a domandarmi se è vero quello che oggi per me è sicuro come la morte: e la preferenza del vino invece che acqua e aceto era ormai una faccenda lontana. Una cosa che pur dandomi parecchio fastidio mi confermava un po' nelle mie idee su Fede era che Jano adesso davanti a lei mi trattava con prepotenza, come per farle vedere la gran diversità tra me e lui, e a tavola quasi ci spiava come se avesse paura che ci parlassimo con gli occhi; in più, sovente parlava di Fede con suo fratello forte apposta perché sentissi anch'io, e diceva delle cose che per Fede come donna potevano essere dei complimenti ma che me mi ferivano dentro.
Però una bella sera riuscii a portarmela da parte una sera che Tobia e Jano erano andati a Torretta a consigliarsi con un particolare che l'anno prima aveva avuto un suo figlio nelle medesime condizioni di Jano ed era stato buono a farselo riformare. Degli altri, Baldino era andato a cuocere a Manera e la padrona accudiva i conigli che erano le bestie alle quali voleva più bene. Io girai la casa e mi postai davanti all'inferriata della cucina, e ci restai tanto impalato e silenzioso che Fede voltandosi si spaventò come se io fossi uno spirito.
- Cosa vuoi?
- Che vieni fuori.
- A far cosa fuori?
- Due parole.
- Facciamole dove siamo.
- Qui non mi va, si sente troppo l'odore dei tuoi parenti Rabino.
- Ma io ho da far cena.
- Anch'io ho da governare le bestie.
- Ma siamo matti? - disse lei; però uscì e io la portai non lontano, dove avessimo potuto sentire anche una mezza voce della padrona. Io volevo che ci riparassimo dietro una siepe, ma lei disse di no, poteva passare qualcuno e una ragazza che per caso si fa vedere con un uomo dietro una siepe è subito criticata, a ragione o a torto. Così si sedette sul ciglio del rittano e io per mettermi alla sua destra saltai giù e poi le passai davanti: lei al volo serrò le gambe e incrociò le mani sui ginocchi. Allora io mi sedetti accanto e le dissi che era proprio una brava ragazza ma che con me non aveva nessun bisogno di star così all'erta.
- L'ho capito subito che sei un ragazzo di buoni sentimenti, - disse Fede: - allora, cos'hai da dirmi, adesso che son qui?
- Mah, n'avrei un bricco di cose. Una è questa: che mi piacerebbe conoscere la tua gente, e che tu conoscessi mia madre che sta a San Benedetto.
- A casa mia c'è poco di bello da vedere.
- Allora non ti farebbe niente d'uscirne.
- Però son sempre i miei.
- Volevo dire, ci pensi a sposarti?
- Che a casa sua stia bene o stia male, una donna è nata per quello.
- Anche tu?
- Perché io no? Se trovo chi mi vuole.
- E l'uomo come dovrebbe essere?
- Niente di straordinario. Basta che non sia zoppo, non sia gobbo e non abbia i capelli rossi. E più che tutto, che lavori e che non mi picchi senza ragione.
- Che sfortuna non essere ancora un uomo.
- Ma tu lo sei già un uomo. Io lo vedo, sai, il lavoro che fai.
- A me mi daresti fiducia?
- Se sarai sempre quello d'adesso, tanta.
- E come uomo ti piacerei?
- Come uomo mi piaci.
Allora dissi: - Se son contento di star da Tobia! Me l'avessero detto solo qualche mese fa. E tu sei contenta di star da Tobia?
Era contenta anche lei, e adesso sarei stato una vera bestia se mi mettevo a cabalizzare sul motivo della sua contentezza. Le dissi adagio: - Ci sono delle schiavenze in giro da prendere.
Lei capì al volo e mi rispose: - E' proprio da lì che bisogna incominciare. Con tanta pazienza e buona voglia.
- Sta' tranquilla che è più facile che il lavoro si spaventi di me che io di lui.
- E' ben per questo che ti do fiducia.
- Allora, Fede, ragazza, lasci fare a me? E quando io ti dica la parola, tu sei pronta?
- Io sono contenta e sarò pronta. Tu hai solo da parlare -. S'alzò e fece: - La mia cena.
Le andavo dietro verso casa, ero perfin balordo per tutta quella fortuna, e un passo più avanti mi venne di colpo paura d'avere una volta fortuna: - Aspetta, dimmi almeno quando ti sei decisa.
Senza voltarsi mi disse:
- Son mica cose che hanno il suo giorno preciso.
- Per combinazione non è stata quella volta che a me hai dato il vino mentre a tutti gli altri acqua e aceto?
Si fermò: - Bestietto, - mi fece, come se avesse una piccola rabbia che io avessi indovinato, e poi: - Però sei intelligente.
Al cancello le domandai ancora se non potevamo trovarci insieme di nascosto qualche sera della bella stagione. - Ma come facciamo? Usiamo pazienza, Agostino, e vedrai che dopo saremo anche più contenti, perché saremo più freschi.
In dieci minuti avevamo saputo dirci tutto e combinar per la vita, e quel discorso valse per dei mesi, per tutte le volte che non potevamo parlarci che con gli occhi, ma mi sembra che non eravamo scontenti di dover tenere il segreto, talmente eravamo sicuri di noi.
Adesso per niente al mondo mi sarei più allontanato dal Pavaglione, fin che ci stava Fede era il posto più bello di tutti. E la domenica era proprio sempre festa: per poca che n'avessi, tutti i sabati sera mi facevo la barba e tutte le domeniche mattina, scendendo a Cappelletto per la messa, camminavo con gli altri uomini dietro le donne e tutte le volte sentivo dai capelli di Fede spargersi nell'aria la mia acqua d'odore.
Jano mi dava quasi più niente fastidio, perché adesso aveva i suoi di fastidi. Quell'uomo di Torretta aveva spiegato che suo figlio era stato riformato perché un tre mesi prima della visita lui gli aveva fatto, un po' ogni giorno, battere sui ginocchi con dei sacchetti di sabbia e così gli erano venuti due palloni al posto dei ginocchi e nello stanzone della leva giù ad Alba i medici militari l'avevano fatto subito rivestire. Tobia voleva che suo figlio si facesse lo stesso trattamento, ma Jano aveva paura di restar disgraziato per sempre e non trovava mai il coraggio di cominciare, e quando Tobia s'infuriò perché il tempo ormai stringeva lui si mise a piangere come un bambino.
A me invece andava tutto al pelo: era tanta la forza e la gioventù e l'allegria in me che adesso rendevo il doppio sul lavoro e Tobia si lasciò prender dall'onta e mi fissò un premio di tre scudi, a darmeli dopo i raccolti. Così potevo fare un po' più bella figura e dare qualche soddisfazione a Fede; come quella volta che la portai a Cappelletto a veder la lanterna magica di quell'uomo di Roddino, e per due soldi a testa ci vedemmo la caccia alla volpe e la donna che faceva correre suo marito con la scopa.
Non volevo neanche più sentir parlare di licenze e, non ho nessuna vergogna a dirlo, l'unico pensiero per i miei era che fossero tutti vivi, perfino Emilio mi veniva in mente da raro e per un attimo. Pensavo solo per me e Fede, e appena avevo un'ora libera correvo all'osteria di Manera dove c'era sempre un certo traffico di gente e cercavo di sapere il più possibile sulle schiavenze; n'avrò sentiti una dozzina, i più pratici, e tutti mi dissero la stessa cosa: per un anno davano cento lire, un quintale di meliga e una brenta di vino. Un affare come i galeotti, ma niente mi spaventava e non avrei fatto smorfie neanche per il posto, al momento buono avrei accettato magari una schiavenza sotto le rocche di Cissone. Ero persuaso di poter fare qualunque riuscita, nel mio piccolo, con Fede accanto, e che la fortuna m'avrebbe sempre accompagnato, da qualunque posto avessi cominciato.
Il tempo volava e in un niente fummo sotto Natale: Tobia e la padrona stavolta mantennero la promessa e portarono me e Fede al mercato d'Alba per regalarci a me un paio di calzoni e a lei il grembiale. Mi ricordo come adesso: a un banco sulla piazza del duomo la padrona mi scelse un bel paio di calzoni rigatini e me li fece provare sopra i miei, e Fede che aveva già il suo grembiale arrotolato sotto il braccio bisognava vedere come discuteva con la padrona e la negoziante e come me li misurava e cercava di vedere i difetti. Proprio come se io fossi già il suo uomo.
E invece ne son venuto in niente. Una porca sera arrivarono a piedi al Pavaglione suo padre e suo fratello e si chiusero in cucina con Fede e coi padroni. Dopo un'ora ripartirono per dove erano venuti, ma portandosi via Fede e il suo fagotto, e lei se n'andava cogli occhi bassi e quando mi passò davanti chinò la testa ancora di più. Io cosa potevo pensare, fuori che sua sorella doveva esser mancata o essere in agonia? Appena potei domandai alla padrona, ma lei mi spiegò soltanto che erano cose di famiglia di Fede; aveva indovinato cosa c'era tra noi due e non avrà voluto darmi un colpo al cuore. Io fui l'ultimo a sapere che Fede era stata chiesta in sposa da uno dei fratelli Busca di Castino e i suoi erano volati su a prenderla nella paura di perder per un'ora l'affare, perché così la loro Fede si sposava nella roba.
- Io li conosco questi Busca? - aveva domandato la padrona a Tobia.
- Li hai visti alla sepoltura di mia cugina Vica, ma forse non li hai presenti. Sono tre boia, neri come il carbone, senza una donna in casa, ma hanno il più bel boccone di terra che ci sia a Castino.
Io ero rimasto come un vitello dopo la prima mazzata. Che m'abbia portato in giro e che abbia voluto solo passare il tempo mentre stava da servente, nessuno me lo farà mai entrare. Piuttosto, presa alla sprovvista, abituata a chinar sempre la testa e senza me vicino che potessi darle la forza di rivoltarsi una volta per tutte, nella paura d'esser legata alla gamba della tavola e cinghiata fino a strapparle il sì, ecco è così che deve aver ceduto, e riguardo a me avrà pensato che ce l'avrei avuta un po' ma poi mi sarebbe passata e me ne sarei cercata un'altra. Adesso m'è quasi passata, ma per un bel po' m'è sembrato d'aver perduto tutta la razza delle donne, perduta Fede.
Mai visto uno sposalizio combinato più al galoppo, nemmeno se Fede avesse sbagliato e ci fosse un bambino in viaggio. Si sposarono a Castino, la prima domenica di febbraio. Tobia e la padrona furono invitati allo sposalizio e ci andarono portando di regalo due asciugamani. Potevano ben andarci anche Jano e Baldino, così avrei potuto starmene una giornata da solo, come n'avevo voglia e bisogno. Invece li ebbi dietro tutto il giorno, che mi tiravano le satire e volevano farmi nientemeno che la porrata, che è una traccia di porri e meliga che si semina verso la porta di chi è stato lasciato da una donna nel giorno che lei si sposa con un altro: uno scherno, ma dissero soltanto di farmelo, perché quel giorno trovavano il ramo che li scorticava. Solo verso scuro potei starmene un po' per mio conto, cogli occhi fissi alla collina di Castino che aveva più lumi del solito, e coi miei ricordi e i miei piani che mi stavano inutili in mano come scatole vuote.
Tobia e la padrona tornarono l'indomani, e con tutto che ci fosse stata una notte in mezzo, Tobia era ancora tanto pieno che teneva tutta la strada. Appena sull'aia allargò le braccia e si mise a decantare la fortuna di Fede, che solo quindici giorni prima era nostra servente e adesso in confronto a lei noialtri eravamo tanti pitocchi. Ma io sentii la padrona fare a Tobia, poi dopo, mentre si riposavano vicino al fuoco: - Sai cosa? Ho paura che quei due boia più vecchi abbiano fatto sposar Fede al più giovane per usarla poi tutt'e tre. Povera figlia.
Quella sera saltai cena, perché non vedessero che non mi restava neanche più la forza di masticare.
Ebbene, nel pieno della malora e che la vita m'era diventata insopportabile al Pavaglione dove non potevo far mezzo passo senza dar nel naso in qualcosa che mi ricordava Fede, la ruota diede un giro e io ebbi un colpo di fortuna, il primo in vent'anni ch'ero al mondo. I nostri zii di Mombarcaro, coi soldi che non sapevano più dove metterli e non buoni a passare il resto della vita a goderseli da signori, aprirono una censa anche a Monesiglio e, per chiamarne un altro, chiamarono mio fratello Stefano da primo garzone. Stefano non aspettava altro che lasciare la terra che tanto era diventata troppo bassa per la sua schiena e io era il mio sogno tornarmene a casa a farla andare io.
Chiesi gli otto giorni a Tobia e lui non ci voleva credere, si fissò che fosse tutta una mia machiavellica per andarmene via più da furbo che Mario Bernasca, ma per fortuna avevo da mostrargli la lettera di Stefano, e allora Tobia mi diede licenza e m'aggiustò il conto: per certo che quella per lui fu una giornata grama perché, non toccherebbe a me dirlo, ma un servitore come me non lo trovava subito passato il cancello.
Feci fagotto e salutai bene, e meglio che tutti gli altri la padrona. Poi dopo non mi voltai più, neanche là dove si comincia a calare da Benevello e si perde la vista del Pavaglione; i quasi tre anni che ci avevo speso me l'ero già dimenticati, quasi che fossero un'elemosina.
Ho fatto quel ritorno come la cosa più bella della mia vita. Era la mia vera festa, e ad Arguello mi fermai all'osteria, comandai una bottiglia di moscato e me la bevetti tutta per festeggiarmi. Mi sembrava di tornare come un soldato, non da permanente, ma proprio dalla guerra. In tutto quel sole l'unica ombra veniva quando gli occhi mi scappavano a guardare alla langa di Castino.
Arrivato a veder San Benedetto, posai il mio fagotto in mezzo alla strada e feci giuramento di non lamentarmi mai anche se dovevo restarci fino a morto e sotterrato e viverci sempre solo a pane e cipolla, purché senza più un padrone. E poi scesi incontro a mia madre, che anche per lei quello era il primo giorno bello dopo chissà quanto.
La casa era malandata: il tetto era tutto da ripassare, il muro verso Belbo gonfio come la pancia d'uno che ha il mal dell'acqua, e dalle impannate ci sarebbe passato un lupo altro che il vento. Ma mi sarei dato da fare anche come muratore e come falegname. Pure la terra era tutta da ripassare, si vedeva da lontano un miglio che Stefano non ci aveva dato dentro. Ma adesso le avrei fatto sentire la mia vanga, bastava che tirassi per mio conto come avevo tirato sotto Tobia, e per poco che la fortuna m'accompagnasse e mia madre m'aiutasse col suo lavoro delle robiole, si poteva sperare di toglierci una buona volta da necessitare, e se poi m'andava diritta diritta un po' d'anni, potevo anche tornare in quello che mio padre aveva dovuto vendere.
Le prime mattine, avevo un bel chiodo, la prima cosa che facevo da alzato era guardare dalla finestra se la mia terra c'era ancora, se nella notte una frana non me l'avesse mangiata, come ho sentito dire che è capitato a gente delle parti di Cissone e di Somano. Quelle poche giornate volevano dire che nella mia vita non ci sarebbe mai più stato un Tobia, e in quanto a Stefano gli avrei liquidato la sua parte appena potevo, già mi sognavo il giorno che andavamo insieme a Dogliani a far lo strumento.
Un po' per giorno venivo a sapere le cose successe mentre io ero via. La più grossa era che non avevamo più la riva da legna. Per far fronte, mia madre e Stefano avevano venduto il resto della riva e d'inverno si scaldavano con la legna che Stefano usciva a rubare di notte. Finché i padroni gli fecero la posta, i Ghilardi del mulino, e mentre che lui aveva le braccia cariche di legna gli saltarono addosso e a momenti gliene davano una di più di quante poteva portarne; mio fratello stette a letto una ventina di giorni, ma alle orecchie del maresciallo di Bossolasco non arrivò niente.
Adesso mi viene freddo nel filo della schiena se penso che alla mira che eravamo non ci voleva più che un soffio a perdere la terra e la casa e restare solo più con le nostre braccia al mondo. E che se ci andava male del tutto, adesso Emilio dovrebbe morire nel suo degli altri.
Sabato passato siamo stati in seminario giù ad Alba io, mia madre e il nostro parroco, chiamati dal rettore. Emilio aveva fatto una cosa ben stravagante: dopo lo studio, s'era distaccato dai suoi compagni e arrivato il bel primo in refettorio aveva dato un morso a tutte le pagnotte che erano già sulle tavole e poi s'era chiuso in un cesso che per farlo uscire avevano dovuto sfondare la porta. I suoi superiori l'avevano subito fatto visitare dal loro medico e gli avevano trovato la tisia, che ce l'aveva addosso già prima che entrasse in seminario. Tutto quello che abbiamo fatto noi giù ad Alba è stato ricevere la notizia e mia madre rispondere alle domande se nella nostra famiglia ce n'erano già stati degli altri. Io e lei ci torcevamo le mani come quando ci tempesta sulla terra, poi quel medico si mise a spiegare a mia madre tutto quello che doveva fare quando riavesse Emilio a casa, e a me il nostro parroco disse da parte che purtroppo non c'era più forza al mondo che poteva salvarlo, se ci fosse stato ancora un lumino di speranza i preti lo mandavano in un ospedale che hanno loro invece di mandarlo a casa a morire in mezzo ai suoi.
Pensiamo se noi ci siamo lasciati scappare una sola parola, eppure tutto San Benedetto sa della malattia d'Emilio e delle donne ci sono già venute in casa a compatire mia madre e farle forza.
Emilio dovrebbe arrivare sabato sera col carro di Canonica che torna dal mercato d'Alba. In fondo al cuore io ho la speranza che si salvi, che lo salvi la nostra aria e il nostro mangiare, ma stasera senza volerlo ho sentito mia madre pregare. Per paura che io fossi in casa e la sentissi, è andata fuori e s'è inginocchiata vicino al primo palo della vigna. Combinazione io ero in quel filare a vedere un melo se buttava bene, e così l'ho sentita dire: "Non chiamarmi prima che abbia chiuso gli occhi a mio povero figlio Emilio. Poi dopo son contenta che mi chiami, se sei contento tu. E allora tieni conto di cosa ho fatto per amore e usami indulgenza per cosa ho fatto per forza. E tutti noi che saremo lassù teniamo la mano sulla testa d'Agostino, che è buono e s'è sacrificato per la famiglia e sarà solo al mondo".